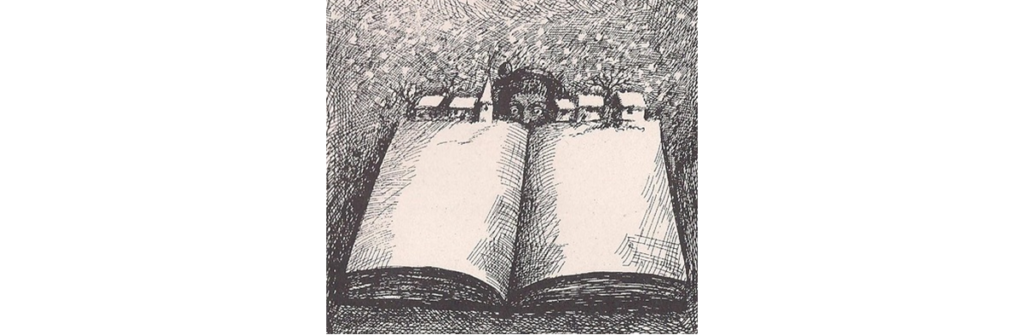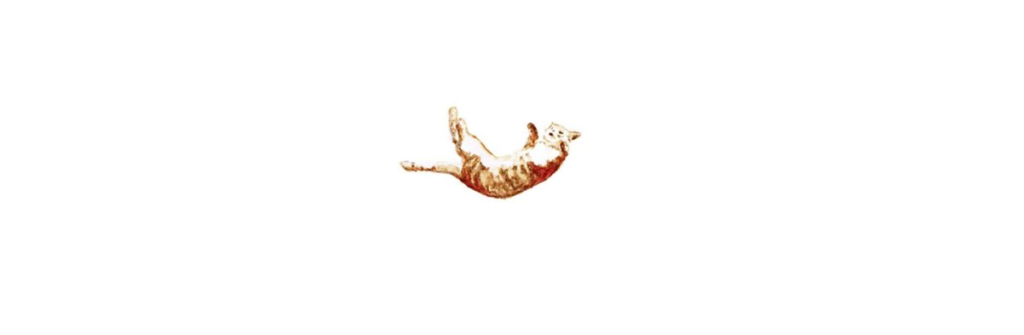Se non ricordo male, e non mi capita mai, è stato Ranieri Carano a definire “res communis omnium” il corpo di Paulette. Paulette è un personaggio dei fumetti creato, nel gennaio del 1970 sulle pagine del numero 12 di “Charlie Mensuel”, da due assoluti giganti come Georges Wolinski e Georges Pichard. Ricca e disinteressata ereditiera di un colossale impero industriale, Paulette Gulderbilt, animata da sincera passione per il riscatto dei disperati, attraversa gli anni Settanta cercando la rivoluzione e uscendo sempre illesa, ma poco (se non per nulla) vestita, dalle più incredibili vicissitudini. Tutti tramano per impossessarsi della sua ricchezza e del suo corpo. Se della ricchezza non le importa nulla, il fatto che il suo corpo sia oggetto delle mire di tutti sembra invece, degna sorella minore di Barbarella, divertirla. Non disdegna il commercio carnale.
Io, a questo proposito, quella di Carano la trovo una bella definizione, azzeccatissima e, in qualche modo, applicabile a tutte le protagoniste di quel curioso “motivo” dei fumetti che si potrebbe chiamare “della fanciulla perseguitata”.
Queste storie, spesso cicliche e ripetitive quasi fino alla noia (non quelle di Paulette, intendiamoci, di cui mi auguro qualcuno voglia fare un’edizione critica che mi offro di curare), non sono soltanto le cronache di una iniziazione sessuale, almeno non nel senso che D’Arco Silvio Avalle attribuisce alla Justine di Sade, cioè di un’iniziazione sessuale imposta a chi la rifiuta in nome di principi etici innaturali, cioè quelli religiosi.
Eroine quali Blanche Epiphanie (Lob e Pichard, 1967), Epoxy (Van Hamme e Cuvelier, 1968), Paulette (Wolinski – Pichard, 1971), Caroline Choléra (Dubos e Pichard, 1978), sono sì candide e innocenti – Blanche Epiphanie ai limiti della stupidità -, ma ogni volta che termina un’avventura durante la quale sono state sottoposte al sopruso, non sono dispiaciute dell’esperienza fatta. Non c’è in loro l’inutile (perché senza possibilità di successo) rifiuto della Justine di Sade (e ci tornerò su, quando troverò le forze per affrontare l’opera di Crepax), e nemmeno la caparbia consapevolezza dell’ingiustizia subita unita alla volontà di vendetta (come nella Marie-Gabrielle del solo Pichard) semmai un’irenica remissione, un’impudenza e un’istintualità quasi panglossiana. Caratteristiche che fanno tornare in mente la saracina Alatiel di Boccaccio (la settima novella della seconda giornata del Decameron), la quale dopo essere «con otto uomini forse diecimila volte giaciuta», va sposa al re Garbo e «allato a lui si coricò per pulcella, e fecegliele credere che così fosse».
Per tutta la novella Alatiel, finita in mano ai cristiani, non viene più chiamata con il suo nome, ma con l’appellativo di “la donna”: espropriata del segno identificatore della propria individualità, Alatiel diventa un corpo pubblico, una comune proprietà degli uomini nelle cui mani, di volta in volta, finisce.
Così Epoxy, privata della propria identità non sa rispondere, a chi le chiede chi sia che in questo modo: «Je… je ne sais pas» e «Qui je suis?… Ha! Je ne le sais plus moi – meme…».
Personaggi a una dimensione, eroine senza personalità, bambole dalle forme giunoniche, corpi e basta, che affrontano tutto quello che capita loro con la placida rassegnazione di chi sa che ciò che accade deve per forza accadere.
Ma allora questi fumetti sono robaccia reazionaria, antifemminista, maschilista! Sì, probabilmente sì.

E’ un dato di fatto che possiamo eliminare solo censurando queste storie. Cosa che, tra l’altro, di questi tempi neovittoriani, troverebbe probabilmente adesioni entusiastiche. Anche se – attenzione! – queste fanciulle di carta sono un po’ più complesse di come sembra a raccontarle. Non sono nelle mani dei loro persecutori (anch’essi di carta), ma in quelle di un demiurgo esterno alla diegesi, colui che la organizza (l’autore? il lettore?). E poi le cose che accadono sono effettivamente ineluttabili, perché stanno scritte. Non nel libro del destino, sia chiaro, ma nella sceneggiatura. Perché il fumetto, come ci ha insegnato Forest, è un mondo chiuso, a parte.
Ho detto bambole a una dimensione. Mi correggo. A due dimensioni, e in senso letterale: quelle del foglio su cui sono disegnate. Bambole che denunciano metalinguisticamente la condizione di ogni personaggio dei fumetti: l’essere proprietà dei lettori. Pensate per un momento a come si conclude la vicenda di Blanche Epiphanie, la quale mentre si allontana verso l’orizzonte sul pallone aerostatico reso più leggero dal sacrificio di Monsieur Dèfendar, pronuncia queste parole: «Je crois que je vous aimais, et cependant je ne connaissais pas votre visage. Je ne saurais jamais qui vous etiez…»
Queste parole non sono solo l’accorato addio per l’eroe che si è appena sacrificato, ma anche il riconoscimento della condizione del lettore: quella presenza senza volto (perché ha il volto di ogni potenziale lettore) che giustifica l’esistenza stessa di Blanche Epiphanie; colui che, per usare parole di Dèfendar, «veille» su di essa, cioè che le fa la guardia come a una sua proprietà, ma anche che sta sveglio a leggere fino a tardi per sapere come va a finire la storia.
«Monsieur Dèfendar, que vais-je devenir sans vous?» si chiede Blanche Epiphanie. Nulla, «ma petite fleur solitaire», perché il racconto è finito, e il tuo florido corpo non sarà, da questo momento in poi, che un fiore secco tra i fogli di carta di un libro, sistemato tra tutti gli altri libri di mia proprietà. Una proprietà comune, perché esistono tanti proprietari di Blanche Epiphanie quanti sono coloro che hanno comprato, o comunque letto, la raccolta delle sue avventure.
Ma allora altro che reazionario, il fumetto e proudhoniano.
Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.