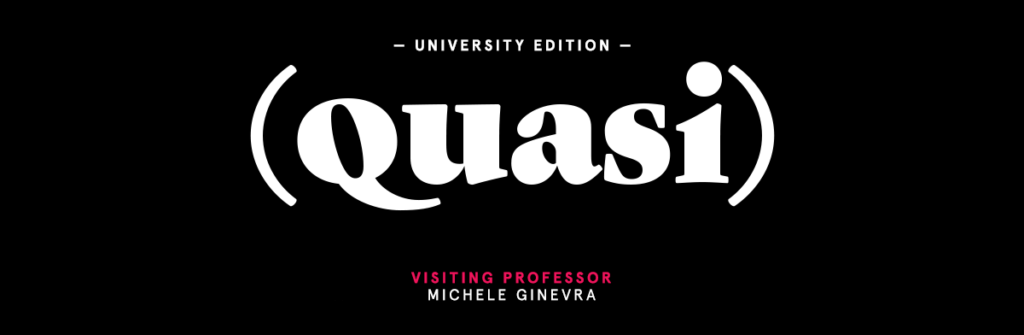Che poi io non sono neanche sicuro di sapere bene cosa sia una pantomima. Sono disciplinato e considero Boris autorevole: non appena propone un titolo, lo assecondo con decisione. Ed è andata così anche questa volta. Avevamo deciso che la nostra storia personale del fumetto, fatta di memorie e critica, doveva durare venti puntate (dieci a testa). Tutti contenti siamo arrivati alla conclusione con un sorriso ebete stampato sul volto. «Mi pare ci sia un problema», ho detto durante una chiacchierata Skype, mostrando la consueta arguzia, «Cosa facciamo adesso il lunedì mattina?». Boris ha allungato lo sguardo sopra gli occhiali, per mettermi a fuoco sullo schermo, e ha detto con assoluta sicurezza «Dopo le Bagatelle, ci sono le Pantomime». Senza aspettare che io gli chiedessi cosa diavolo sono, ha aggiunto «E queste vengono dal Calisota». Quanto mi conosce Boris, quanto conosce le mie debolezze: il nome di quello stato è l’apritisesamo per il mio cuore di pietra.
Ora sono qui a scrivere Pantomime e l’allegria indottami dal passeggiare nelle strade di Paperopoli si sta un po’ affievolendo. Dannazione! Cos’è con precisione una pantomima? Una delle tante parole di cui, nella vita, ho dedotto il significato dall’uso che se ne faceva le volte in cui l’ho incontrata. Ma mica me la sono mai fatto spiegare. Mica l’ho cercata sul dizionario. Approfitto della mia connessione internet e ne cerco la definizione sul vocabolario Treccani. Dice che è una «rappresentazione scenica muta, in cui l’azione è affidata unicamente al gesto, all’espressione del volto, ai movimenti del corpo, alla danza, talora anche con accompagnamento musicale». Poi specifica che vengono chiamati così i cortometraggi comici del cinema muto. Infine, nella seconda definizione, specifica che, per estensione, quel nome viene usato per indicare la «gesticolazione vivace e eccessiva […] da parte di chi vuole farsi intendere senza parlare».
Mi perdo in quella definizione perché, mentre oscillo tra Buster Keaton e l’agitarsi frenetico del mimo improvvisato, mi si stampano davanti agli occhi le pagine in cui Marcel Gotlib costruisce un crescendo scenico di gesti convulsi ed esasperati. Personaggi circondati da linee cinetiche e tratti nervosi che, dopo alcune vignette che muovono verso un orgasmo, riconquistano la calma garantita loro dall’immobilità del disegno.
Afferro alcuni libri e li sfoglio, per vedere le pantomime di Gotlib. Ci prendo gusto e, dopo aver sfogliato i volumi che contengono Rubrique-à-brac, mi dedico ai miei preferiti. I tre libri intitolati Rhââ Lovely raccolgono le storie per adulti realizzate per le riviste che l’autore sentiva più sue, “L’Écho des savanes” e “Fluide glacial”. In quei volumi ci sono i suoi mondi: gli dèi più umani degli umani, i supereroi panzuti, gli scienziati nel momento stesso della grande scoperta, gli stereotipi sociali catturati nella loro umanità schifosetta. A un certo punto, mentre sfoglio il secondo volume, mi imbatto in un fumetto di una tavola. È una pagina strana e bellissima. Un Gotlib così diverso da quello che sono abituato a vedere che non può essere lì per caso.
C’è un omino che cammina libero. È apparentemente felice e spensierato. Crede di godere di una libertà illimitata. Il sole è caldo e quella sensazione sulla pelle, liscia e priva di peli o asperità, è tutto ciò di cui crede di avere bisogno. Poi, senza causa apparente, senza essere passato dal via, la sua libertà finisce. Un muro è una prigione, anche quando lo si può costeggiare in eterno impedisce di andare oltre. Un muro è una sfida, richiede evasione.

Appoggio il volume, ma quella pagina non mi molla. Faccio altro: lavoro, cucino, gioco, chiacchiero… Ma quella pagina è sempre lì con me. Il titolo con cui è riportata nel volume dà coordinate chiare: Les trompettes de Jéricho 72. Cerco di capire dove sia stata pubblicata originariamente e scopro che viene dal secondo numero de “L’Écho des savanes”, datato gennaio 1973. Grazie a “BD oubliées” scopro che quel numero della rivista aveva una copertina disegnata da Gotlib occupata da uno dei suoi faccioni con bocca spalancata. Seduto sulla lingua un tipo legge il giornale e dice: «La porta!».
L’omino che si è trovato improvvisamente di fronte al muro non demorde. Si guarda attorno e trova un giocattolo composto da un cazzo e una merda legati con una cordicella. È uno di quei giochi che trasformano ogni bambino in un giocoliere: con colpi calibrati del polso, bisogna infilare il cazzo nella merda. Quando finalmente l’omino ci riesce, il muro crolla. Si può evadere. Si può andare oltre. La destinazione non è importante.
Quel fumetto, raccontato con poche vignette e senza nessuna parola, se non quelle presenti nel titolo, ci dice di una rivoluzione. Siamo abituati a concentrarci sul famoso editoriale scritto da Moebius per il quarto numero di “Metal Hurlant” e pubblicato alla fine del 1975, quasi tre anni dopo questa pagina di Gotlib. Moebius, oltre a rivendicare la possibilità di costruire le famose storie «in forma di elefante, di campo di grano, o di tremolante fiamma di fiammifero», poneva dei quesiti molto duri ai lettori che cercavano sicurezza e consolazione nelle narrazioni. Chiedeva:
«Ma se il messaggio politico è sempre implicito, perché evidenziarlo? Perché attendere la fine della storia per contraddirsi? Perché fare vincere il più debole? Perché avere paura di ritrovarsi soli nel buio e gridare aiuto? Perché tutta quest’ansia di avere ragione?»
Una spallata a quelle storie in forma di casa in cui narratori, attenti sempre agli stessi elementi («il climax, l’avventura, il messaggio, la morale, le gag»), stavano rinchiudendo le storie stesse e i lettori. Una prigione narrativa in cui si finiva senza passare dal via e senza il bisogno di pescare l’odiata carta degli imprevisti del Monopoly.
Tre anni prima, senza proclami scolpiti in un’editoriale da citare con orgoglio, senza usare neanche una parola, con un cazzo e una merda, il gigantesco Gotlib dimostra che quel muro si può abbattere. Basta affidarsi unicamente al gesto, all’espressione del volto, ai movimenti del corpo, alla danza, per farsi intendere senza parlare.
Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di QUASI.