Nelle scorse settimane mi è capitato di chiacchierare con qualche amico. Tra dialoghi distesi, cazzeggio, pettegolezzi e qualche birra, si arriva sempre a ciarlare di QUASI, rivista che non legge nessuno ma attorno alla quale si consumano un sacco di parole. A quel punto dico al mio interlocutore che Boris e io sentiamo il bisogno di dire la nostra sulle cose che leggiamo, che vogliamo iniziare a inserire in QUASI delle recensioni. Appena lo dico, il malcapitato su cui rovescio, con fare ossessivo, i miei rovelli mi fa sempre un paio di domande.
La prima è sempre un’arguzia: «Lo sai, vero, che la promessa di parlare solo del bello, del buono e dell’utile va a farsi benedire?». E, lì, me la cavo con facilità. Dico che mica è necessario recensire sempre e solo le ultime novità del mercato editoriale italiano. Possiamo raccontare pubblicazioni uscite da un po’, in diverse lingue, e ancora reperibili (non necessariamente in ottemperanza al diritto d’autore). Poi, anche dovesse capitarci di parlare di cose che non ci sono piaciute, l’importante è che la loro presenza ci sia stata utile a mettere a fuoco un tema, un nodo, una questione.
Poi arriva la seconda domanda, quella difficile. «E come le volete fare queste recensioni?», chiede il mio amico. Lo guardo per qualche istante e poi, allungando ogni vocale, rispondo, «Eeh? Coosainteendii?»
So benissimo che la recensione è un genere letterario. E so anche che QUASI non offre servizi al sistema dell’editoria a fumetti: la specifica delle caratteristiche tecniche e commerciali di un prodotto, utili a fornire indicazioni che aiutino il lettore a muoversi nello spazio delle merci, non ci interessa. L’industria e il mercato editoriali sono ambiti dai quali abbiamo scelto, con coscienza e oculatezza, di tenerci alla larga. QUASI è un blog, privo di sponsor pubblicità e comunicati stampa, ed è una rivista pubblicata da un’associazione culturale che si tiene ben lontana dal commercio. Abbiamo fatto nostro uno dei Proverbi afghani di Filippo Scòzzari: «Se non compri e non vendi, cazzo ci fai nel bazar?» Niente. Nel bazar non abbiamo intenzione di metterci piede.
«E vabbè», dice il mio amico, «non si capisce niente» e sbuffa. «Alla fine farai, come sempre, la tua cosa. Ti perderai tra gnommeri, strani anelli e bagatelle… fa’ almeno un esempio!». Sospiro e mi costringo a non montare sulla difensiva.
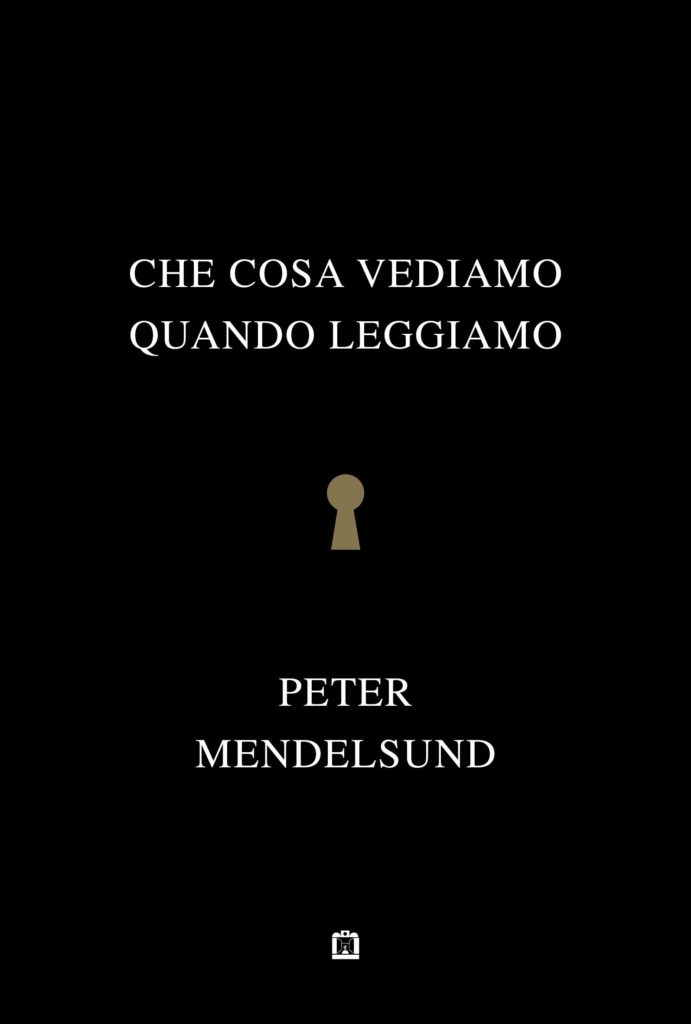
Il nero della copertina è interrotto solo dal bianco con cui sono stampati il logo dell’editore e i caratteri bastone del titolo e del nome dell’autore. Nel mezzo spicca il buco di una serratura, impresso con un inchiostro argentato. La prima cosa che penso, quando vedo quel libro, è che il libraio abbia sistemato male un memoir erotico, uno di quelli che hanno titoli imprecisi che ammiccano e non portano da nessuna parte: I segreti della dark room, Red, The Surrender, … cose così. Però il logo è quello di Corraini e il volume è pesante. Oltre quattrocento pagine, direi, e i bordi mostrano le striature grigie tipiche dei libri che alternano pagine bianche e nere. Ci passo il pollice e, scorrendo, osservo quella successione di pagine interamente dedicate alla parola e altre alle immagini. Mi pare mi si voglia far pensare ai libri di Brian Selznick che tanto amo. Il titolo, Che cosa vediamo quando leggiamo, pone una questione irresistibile. L’assenza di punto interrogativo mi promette risposte. Un’ultima occhiata alle pagine interne, fino ad arrivare alla nota biografica di Peter Mendelsund, l’autore: è art director di Alfred A. Knopf e Pantheon; il “Wall Street Journal” dichiara che le copertine che realizza sono «le più iconiche e immediatamente riconoscibili del mondo della narrativa contemporanea».
Il libro viene con me e monta in cima alla pigna delle letture, scavalcando un sacco di roba che è affastellata lì da mesi, forse anni. Il titolo completo è Che cosa vediamo quando leggiamo: Una fenomenologia con illustrazioni. Ecco la chiave per aprire la serratura argentata impressa in copertina: «con illustrazioni», è tutto lì. Le parole e le immagini sono nettamente separate e non hanno alcuna intenzione di convivere. Eppure Mendelsund è un professionista delle immagini e della grafica: nel mio mondo ideale è colui che armonizza tutti gli elementi che devono convivere nel libro, alla ricerca del più alto grado di efficacia ed efficienza, minimizzando le ridondanze e gli sprechi. Trovo incredibile che un individuo con la sua storia e la sua posizione sia così spaventato dalle immagini.
Sembra quasi che l’autore voglia adattare al formato picture book Lector in fabula di Umberto Eco, senza aver capito un granché di cooperazione interpretativa. Il suo è un mondo di parole in cui le immagini sono solo un supporto decorativo. Non raccontano, non informano, non spiegano, non integrano, raramente divertono. Quelle figure gli servono solo a garantire che il lettore non abbandoni il suo libro per afferrare il cellulare o guardare il mondo. Gli interessano solo le parole e le circonda di immagini, in ogni pagina, quasi sempre arbitrarie e incoerenti, incapaci di creare senso.
Ci sono, nel libro di Mendelsund, incitamenti reazionari inattesi. E mi stupisco osservando come un editore che considero attento e sensibile, come Corraini, abbia inserito con noncuranza nel proprio catalogo un libro che suggerisce che la trasformazione visuale delle narrazioni stia traducendosi in uno strumento di regressione cognitiva che fa perdere agli umani la capacità di vedere storie nella propria immaginazione.
Mendelsund mostra un’attenzione spasmodica a mantenere una distanza siderale da qualsiasi trattazione scientifica della visione. A un certo punto dichiara questa lontananza esplicitamente. La lascia cadere in una nota a piè di pagina (ce ne sono a bizzeffe, quasi fossero una trovata grafica):
«Cosa viene chiesto al lettore? Di non vedere? E su questa convenzione che si basano alcuni generi letterari, come ad esempio la fantascienza, l’horror…*
* O la moderna fisica teorica.»
Chiunque abbia fatto qualche esercizio di scrittura sa che, se in un elenco, prima dei tre puntini, si inseriscono solo due esempi, significa che quell’enumerazione esemplificativa non è chiara neanche a chi sta scrivendo (non esiste nella sua immaginazione, direbbe Mendelsund).
C’è poi la somiglianza fisica tra Che cosa vediamo quando leggiamo e La straordinaria invenzione di Hugo Cabret. Nel libro di Brian Selznick le parole e le immagini sono in equilibrio perfetto; l’alternanza di caratteri alfabetici e figure produce un oggetto narrativo infallibile. Nel libro di Mendelsund sembra spesso che le figure servano solo ad aumentare il numero di pagine del libro e lo spazio che quella costa occuperà sulla mensola. Le immagini scelte sembrano decorative o ridondanti. A un certo punto, l’autore fa un gioco con l’immaginazione del lettore: gli chiede di prendere una D, di farla roteare di 90° in senso antiorario e di porla su una J. Poi, per spiegare quello che succede nell’immaginazione del lettore a fronte di quelle parole, dilapida quattro pagine di pioggia e schemini intrise di esasperante didascalismo.
«Ma che ti ha fatto ‘sto Mendelsund?», chiede l’amico, «Sembri veramente incazzato».
A quel punto estraggo il libro dallo zaino, lo apro e leggo:
«Nonostante l’immaginazione e la comprensione siano diverse dalla visione oculare, accettiamo la metafora dell’immaginazione come sguardo rivolto all’interno. L’immaginazione è una presa di distanza da quel mondo che è indipendente dalla mente. Ne deduciamo, per altro, che lo sguardo rivolto all’esterno non sia che un ostacolo al mondo interiore (Omero, Tiresia).»
Il mio amico spalanca gli occhi, in modo quasi innaturale, per lo sbalordimento. Li chiude, quasi volesse conservarli nelle orbite, e scuote il capo costernato. Li riapre solo per levarli brevemente al cielo. Poi, chiede un’altra bottiglia.
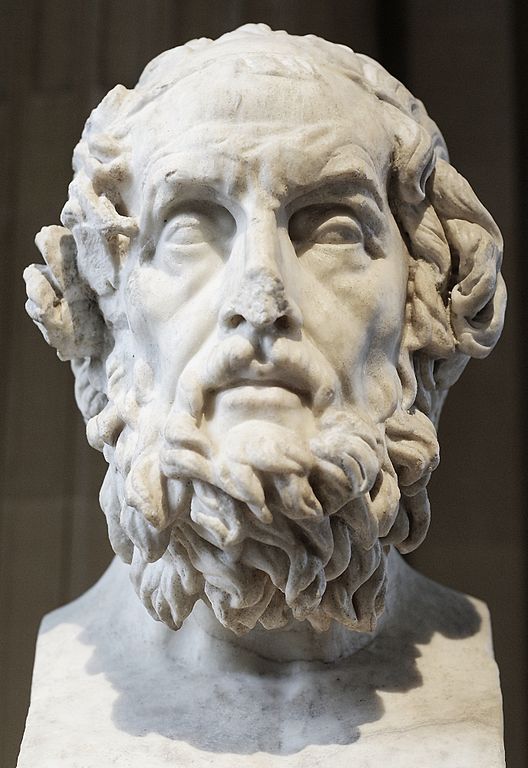

Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di QUASI.



