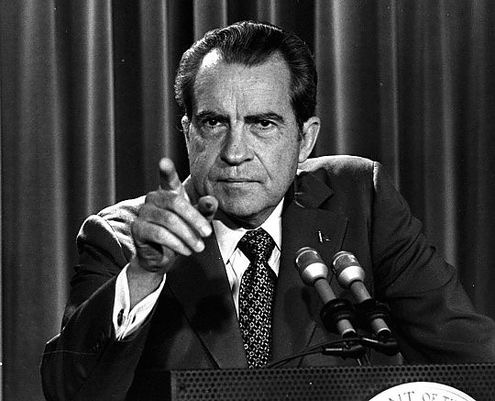
Pare che la furbizia sia un pregio. Una qualità anche più importante dell’intelligenza. Un tipo furbo è anche simpatico, arguto, capace di farsi strada. Nelle organizzazioni ne trovi a bizzeffe in posizioni di potere. Sanno sempre cosa fare, con cattiveria e determinazione, e se abbassi la maniglia davanti ai loro occhi, cento o duecento volte, imparano addirittura ad aprire una porta e a entrare in una stanza.
La furbizia è così importante per il lavoro che, per dare nobiltà al nostro continuo essere su Zoom, Teams o Meet, in riunione con colleghi, clienti e fornitori, abbiamo inventato la locuzione “lavoro furbo”. Poi siccome se ce lo diciamo in italiano, ne capiamo il senso e ci sentiamo cretini, preferiamo usare una locuzione inglese.
Intendiamoci. Lavorare da casa non è male (non lavorare è anche meglio). Ma un conto è l’attitudine a carpire quella possibilità, impossessandosene con uno sporadico sotterfugio, un altro è esserne costretti con sistematicità. Nel primo caso, godi di cose piccole come il non doversi infilare in mezzi stipati di individui cui, a volte, farebbe bene una doccia e un cambio di camicia, e di cose grandi come la possibilità affrontare una riunione noiosa, alle 11.00, armato di birra e anacardi; nel secondo, ed è la mia attuale situazione, non sei nella stessa stanza con i tuoi interlocutori da così tanto tempo, che ti convinci che l’umanità è finita e stai interagendo con registrazioni per non impazzire (ed effettivamente, sullo schermo, tutti dicono sempre le stesse cose, indifferenti alla freccia del tempo).
Dopo una giornata di “lavoro furbo” cerchi di ristabilire un contatto con la realtà. Con la testa pesante e le orecchie che ronzano, dopo che sei stato in riunione con umani che farfugliano, berciano, garriscono, landiscono, grufolano e rantegano, cerchi con tutta la tua forza di recuperare un contatto con individui che dicano cose sensate. Siccome, uscire di casa è uno di quei peccati che non danno più neanche piacere, spegni il computer, afferri il cellulare o il tablet, e inizi a guardare la timeline di Facebook, Twitter e Instagram. Distribuisci pollici e cuoricini, per rimarcare la tua esistenza. Poi, con occhi di carta vetrata, ti trascini fino in cucina, ti versi un bicchiere e prepari la cena.
Oh, merda!
Va bene. Avrà una qualche utilità questo maledetto cellulare che mi porto sempre appresso. Un qualsiasi uso che vada oltre la mirabolante possibilità di distribuire apprezzamenti su post di persone che non conosco e che non sanno chi sono: «Uno a caso e altri 12 amici hanno aggiunto una reazione alla tua storia». Cerco una libreria nei dintorni, perché non è possibile che, una dopo l’altra, siano tutte morte. Il motore di ricerca interpellato è implacabile: c’è il punto vendita di una catena collocato in un centro commerciale in cui non metterei piede neanche se non ci fosse il Covid; un altro negozio grandi marchi in un altro centro commerciale; un altro ancora… E questa? Questa cos’è? Meno di cinque chilometri. È vicinissima. Ha un nome strano e una descrizione ancora più stravagante. Vende libri e caramelle: che accoppiata di merci inusuale. Chi se ne frega! È qui dietro. Scrivo l’indirizzo sull’autocertificazione e ci vado di corsa, tenendo le dita incrociate e pregando divinità sparse, nella speranza che non si accorgano del mio ateismo e si facciano fregare.
Uno degli dei in cui non credo deve essere compassionevole o facile da turlupinare. In una via più bella di quanto ricordassi c’è un porticato. Lì sotto c’è un bel negozio: duecento metri quadri, tre vetrine, un bell’assortimento di libri per bambini, un po’ di saggi e romanzi, un sacco di articoli da cartoleria e pure le caramelle. Ci sono stati momenti della mia vita in cui, davanti a un libreria così, con un sorriso carico di spocchia, non avrei nemmeno rallentato il passo. Quel tempo è passato: oggi questa libreria mi pare bellissima. Ci entro e mi attardo passando con il dito tutti i titoli. Ne trovo addirittura qualcuno da comprare. Pago e, all’uscita, vengo intercettato da un signore distinto con la mascherina che ha anche lui in mano il sacchetto di carta della libreria. Mi sorride – lo capisco dagli occhi – e, con educazione, mi chiede cosa ho comprato. Ha voglia di parlare e io pure. Ci sediamo sul muretto all’incrocio, chiedendoci se stiamo violando i precetti dell’ultimo dpcm. Nessuno dei due lo sa e decidiamo di rischiare. Mi parla del suo amore per Philip Roth, non si scandalizza quando gli dico che sono un lettore di fumetti, dopo dieci minuti siamo amici. Ci mancano solo i bicchieri.
A un certo punto mi racconta cosa fa di mestiere: dice di lavorare nell’ufficio legale di un “grande editore” e di trascorrere le giornate redigendo e analizzando contratti. Con gli autori e con i distributori, soprattutto. Mi dice che gli piace guardare in faccia quelli come me. Quelli che fanno ancora acquisti in libreria. Sa che il mercato sta per assumere un’altra forma e nessuno vedrà più quella particolarissima soddisfazione che si legge solo negli occhi di chi ha trovato il libro che voleva leggere.
Mi trattengo e non faccio battute sulla visione romantica del mio nuovo amico. Sono curioso e voglio che mi racconti una storia. Maledico l’assenza di vino e lo ascolto. Non posso essere sicuro né della veridicità né di aver capito quello che mi dice. Ma sembra un racconto distopico infernale e ha il suo fascino.
L’editore per cui il mio nuovo amico lavora ha un contratto con un distributore che gestisce in esclusiva i rapporti con un grandissimo sito di commercio elettronico internazionale, il più grande di tutti. Non dice mai i nomi delle aziende coinvolte e non lo farò neanche io.
Mi dice che questo sito di e-commerce si comporta apparentemente come un qualsiasi libreria, ha un contratto con il distributore, uno sconto pattuito con l’editore, la possibilità di resa. Una libreria come tutte le altre: ordina i libri, li riceve, paga l’anticipo e poi li vende; dopo un po’ può rendere i libri e salda o riscuote. Mi dice: «Esattamente come una libreria o una catena di librerie: solo che è una catena di librerie fatta da una sola libreria e quella libreria ha in mano il 60% del nostro mercato nazionale.»
Strabuzzo gli occhi incredulo. Cerco di non sembrare offensivo, quando gli chiedo conferma della percentuale abnorme e lui, senza scomporsi, rilancia: «Un po’ di più.»
Semplificando un po’, Il distributore paga le copie che il promotore, in accordo con la rete di vendita, ha stimato. Di solito le librerie più grosse lavorano con una stima di vendita (la chiama “conto estimatorio”) concordata con il promotore sul lancio di ciascun titolo e poi, mese dopo mese, pagano quello che hanno venduto. Ecco, il distributore manda in giro un certo numero di copie, avendo una anticipo sulla stima di vendita.
Il grande sito di commercio elettronico è il cliente più grande di tutti e, per questo motivo, ha un contratto con uno sconto maggiore. Paga al distributore tutte le copie che ordina – come fa la più grande catena di librerie in Italia, ma si sa che smetterà nei prossimi mesi – e incrementa gli ordini, mese dopo mese – e i suoi ordini sono molto più grandi di quelli della più grande catena di librerie italiana. Fa pochissime rese, pur avendone il diritto, perché dice che l’algoritmo garantisce che quelle copie saranno vendute. Ha una rete logistica mondiale di dimensioni impressionanti e i suoi magazzini sono giganteschi, più grandi del più grande centro commerciale che ognuno di noi abbia mai visto: ha tutto lo spazio per accumulare materiale invenduto. Che un giorno, volendo, potrà rendere.
Aggiunge un’informazione che sembra accessoria e mi dice di tenerla bene a mente, perché potrà essere utile. Mi parla della legge Malfatti (di cui non trovo alcun riferimento in rete). Mi spiega che il magazzino di un editore perde valore ogni anno fino ad azzerarsi in cinque anni, con le normali regole di ammortamento, perché altrimenti si dovrebbero pagare sui vecchi prodotti le stesse tasse previste per i nuovi. Un editore che conserva tutto il suo catalogo, riempie i suoi costosissimi magazzini di oggetti che hanno un grande valore culturale e, forse emotivo, ma che non valgono nulla ai fini del calcolo dell’imponibile (e del valore dell’azienda). Così si spiega il fatto che i libri vanno al macero o, nel caso migliore, nella rete dei remainders. Perché quei libri invenduti non possono essere considerati come beni di riserva che accrescono il valore dell’azienda. Anzi…
A questo punto mi guarda e dice: «Immagini se un giorno, non troppo lontano, quel grande sito di commercio elettronico, che in questo momento ordina il 60% dei nostri libri, ci imponesse unilateralmente uno sconto per noi insostenibile. E, di fronte al nostro pallido tentativo di rifiuto, ci presentasse davanti alla porta i nostri libri invenduti chiedendoci il denaro che ci ha anticipato. Avremmo solo due possibilità. Rifiutare, conteggiare il valore del nostro debito e riprenderci dei libri che non valgono più niente e hanno un enorme costo di magazzino. Accettare e perdere punti di redditività fino a dover cambiare modello di produzione. A quel punto, potremmo diventare, come si dice oggi, un content provider per un grande sito di e-commerce che, nel frattempo ha imparato a costruire il prodotto finito on demand. La fine della distribuzione, dei grandi editori e delle librerie tradizionali. Stiamo infilando il futuro dell’editoria nelle fauci del lupo. È spaventoso.»
Mi dice che si è fatto tardi, mi saluta quasi bruscamente, si alza e se ne va. Mi lascia da solo, all’incrocio. Non ci siamo neanche presentati.
Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di QUASI.



