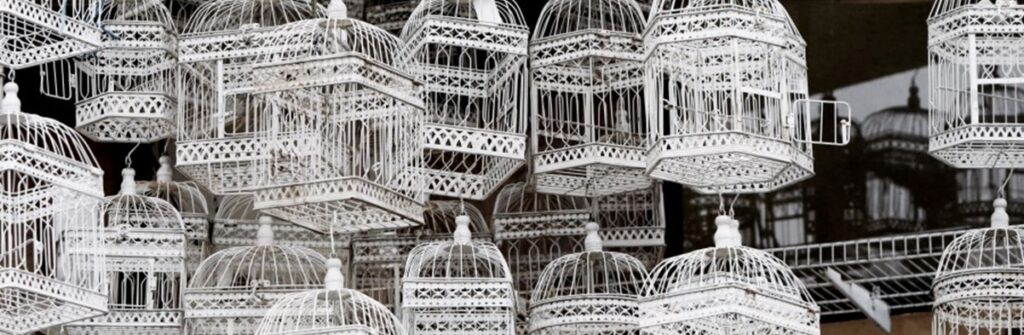Si era ancora nella prima decade del millennio nuovo e il basso lo si era appeso al chiodo già da qualche anno, da quando si era trattato di mettersi per strada in cerca di una situazione lavorativa un po’ meno peggiore di quella precedente. Non che la pratica musicale godesse di ottima salute prima dell’interruzione: c’era poco tempo, le prove settimanali insistevano su pezzi che a volte erano pure un po’ troppo complicati rispetto alle capacità del momento (un esempio su tutti, No One Knows dei Queens of The Stone Age), lo studio era praticamente inesistente. Fatto sta che quando arriva il momento di mollare la versione più recente di vita, il basso torna nella custodia e lì resta per qualche anno – non troppi, anche se per tornare a una modalità simile a quella appena raccontata, molto da diporto, con pendolarismo serale/notturno per raggiungere i luoghi delle prove. La verità vera è che di periodi un po’ più «seri» ce ne sono stati pochi – all’inizio, circa trent’anni fa, e, ironia della sorte, in tempi recenti, negli ultimi anni.
Insomma, il bassista da salotto non solo non è un granché come musicante ma non lo è neppure stato con continuità. Ecco quindi che fa capolino, o meglio, si impone quasi, anche perché dopo un po’ che ci si avvita su sé stessi iniziano a prendere i capogiri, l’esigenza di tirare in ballo un taglio diverso per gli scribacchiamenti del sottoscritto qui su QUASI. Non ci sono state discussioni e riflessioni particolarmente approfondite, lo spunto è emerso alla velocità con cui crescono le infestanti in giardino: perché non mettersi a fare qualcos’altro (come se il resto avesse una sua norma o una sua rotta…) rispetto al solito e non provare, che ne sappiamo, la strada delle recensioni, o qualcosa di simile? Detto, fatto. Ed ecco che accade proprio come quando in giardino accogli il trifoglio, un’infestante, come una benedizione, perché non sei riuscito a far crescere quelle maledette essenze del miscuglio che hai comprato, in ordine cronologico, al crescere delle tue competenze, da Leroy Merlin, al vivaio, dal negozio specializzato online. Il trifoglio va benissimo. Il pratino dei miei stivali, compatto, verdissimo, freschissimo, è un abominio di difficoltà tecnica di progettazione e mantenimento, insostenibilità ecologica e violenza chimica degna di una IG Farben e dei suoi epigoni. Spesso, quindi, si passa del tempo chini a scalzare cespi di erbe brutte e resistenti con un coltello a lama flessibile, ma quando non sono troppo brutte ci si arrende e si lascia crescere quel che riesce a farlo. Nasce così la rubrica Interni di un bassista, che se uno mette il titolo accanto a quello dell’altra, viene paura di essere dal proctologo, o peggio. Ma tranquilli, non c’è niente di endoscopico né strani traffici in prossimità di orifizi – il fil rouge, al limite, è quello di una pur sempre tranquillizzante scarsissima considerazione da parte del vasto pubblico là fuori. Nessun rilancio, o rincaro di dose, se non ve lo filavate prima, continuerete a non filarvelo. L’idea, rigorosamente vagliata dopo aver lanciato il titolo della nuova rubrica, è solo e soltanto quello di fare un po’ più di spazio e vedere cosa ci cresce dentro. Il pretesto è quello di andare a pescare nel baule del vissuto e raccontare di pezzi, scampoli e brandelli e capire se cambia qualcosa, se ci scorre dentro un di più, un di meno, o se siamo sempre e comunque sulla rotta narrativa che si è venuta a creare di là.

Come avevo iniziato a dire, prima di sperdermi, in una di quelle epoche di mezzo senza basso e praticamente senza salotto, non c’era neppure una distinzione nettissima tra zona giorno e zona notte, vivevo a Milano, o meglio, poco fuori, nel continuum mediolanumense, e avevo appena finito un periodo di trasferta permanente (ma solo nei giorni feriali) a Torino. Al mio ritorno a Milano l’azienda per cui lavoravo trasferì con prontezza la sede esattamente agli antipodi della città e, pressoché contestualmente, mi assegnò a un cliente che si trovava, guarda caso, proprio in quella zona. Morale della favola: ventisei fermate di metro all’andata, ventisei al ritorno. Quasi due ore di tempo da passare in qualche modo. Non essendo l’originalità un’esigenza, la scelta naturale fu lettura e musica.
La mia conoscenza dell’opera di Thomas Pynchon è stata guidata, anche se non ricordo esattamente come, da quale riferimento preciso, dall’aver studiato il rapporto tra esperienza bellica, narrativa e identità. Da qualche parte, qualcuno dei saggisti a cui mi sono appoggiato per scrivere una tesi di laurea che paresse un minimo dotata di verve deve aver scritto, magari con una citazione, una motivazione… Ecco, me la sono ricordata (senza aiuto della rete, giuro): il tema era fango, merda e morte a Passchendaele, e il saggista era Paul Fussell. Non è niente di carino, ma d’altra parte non lo era neppure la materia dei miei studi. In Gravity’s Rainbow, e siamo nella seconda guerra mondiale, il generale Pudding, che nella prima aveva combattuto nel suddetto mischione di palta, morte e materiali biologici prodotti dai vivi e dai morti di quel teatro di guerra, è nominalmente a capo della White Visitation, una misteriosa sub-agenzia di intelligence dedita alla ricerca di metodi quantomeno esoterici per combattere i tedeschi, ma in realtà è solo una figura inconsistente, manovrata dallo psicologo comportamentale Pointsman, fanatico pavloviano. E così Pudding non riesce a far di meglio che indulgere nelle proprie inclinazioni masochistiche, consegnandosi alla mercé della domina Katje Borgesius, una torbida, irresistibile e puntualmente bionda olandese che in realtà spia per i tedeschi. Vi risparmio i dettagli, perché si parla di materia fecale e di passaggi non esattamente invitanti con utilizzi poco gradevoli della materia in questione.
Comunque, Gravity’s Rainbow è una lettura così avventurosa, vuoi per le dimensioni del volume, vuoi per il casino che ci avviene dentro, sia in termini narrativi che di uso e abuso di un fuoco di fila di riferimenti culturali che i fan ci hanno messo su delle wiki per orientarcisi. E bene o male tutti i libri di Pynchon sono così, impegnativi, iniziatici, epici ma pure scassati e scanzonati – non la si sfanga con centocinquanta pagine. Se pensavate di avere scoperto modi di scrivere così con Infinite Jest di DFW, Gravity’s Rainbow è del 1973. [Verso il 2000 il critico James Wood ha rimesso insieme Pynchon, DFW, DeLillo e altri nella definizione, non so quanto riuscita, ma non so un tubo di critica letteraria, di hysteric realism]
Lasciando stare il resto della produzione pynchoniana – non ho letto Mason & Dixon e un sacco di altre cose, ho letto V (e non ricordo praticamente niente) e Inherent Vice (e ho pensato: «meh») – per me il clou è stato rappresentato da Against The Day. Qui, veramente, non ricordo come ho deciso di leggerlo, in lingua originale, per giunta, edizione Penguin per un totale di mille ottantacinque pagine. Fatto sta che sulla metro rossa (la linea 1, finché non ci si è abituati alla prevalenza del colore sul numero) inizio ad affrontarlo, da subito, se, di nuovo, la memoria non mi inganna, appaiato con quella che oggi mi sembra la scelta del tutto inevitabile di «colonna sonora» per le storie di Against the Day: 10000 Days dei Tool.
Il romanzo si muove in un’epoca storica che prende di sorpresa. Ci troviamo tra la grande esposizione universale di Chicago del 1893 e la prima guerra mondiale, la Belle Epoque, in sostanza, solo che quello che Pynchon ci mostra non è la cartolina parigina o edoardiana di un mondo di mezzo, tra decadentismo, simbolismo e art nouveau, è piuttosto il terreno di battaglia tra forze antilibertarie, retrive e anti-vita, promosse, foraggiate e stipendiate dall’élite capitalista, e rari, dispersi, individui o gruppi, più o meno dichiaratamente anarchici. Sullo sfondo di un mondo dove i prodigi della tecnica non viaggiano dissociati da manifestazioni un po’ magiche, un po’ parascientifiche, un po’ pseudoqualcosaltro.
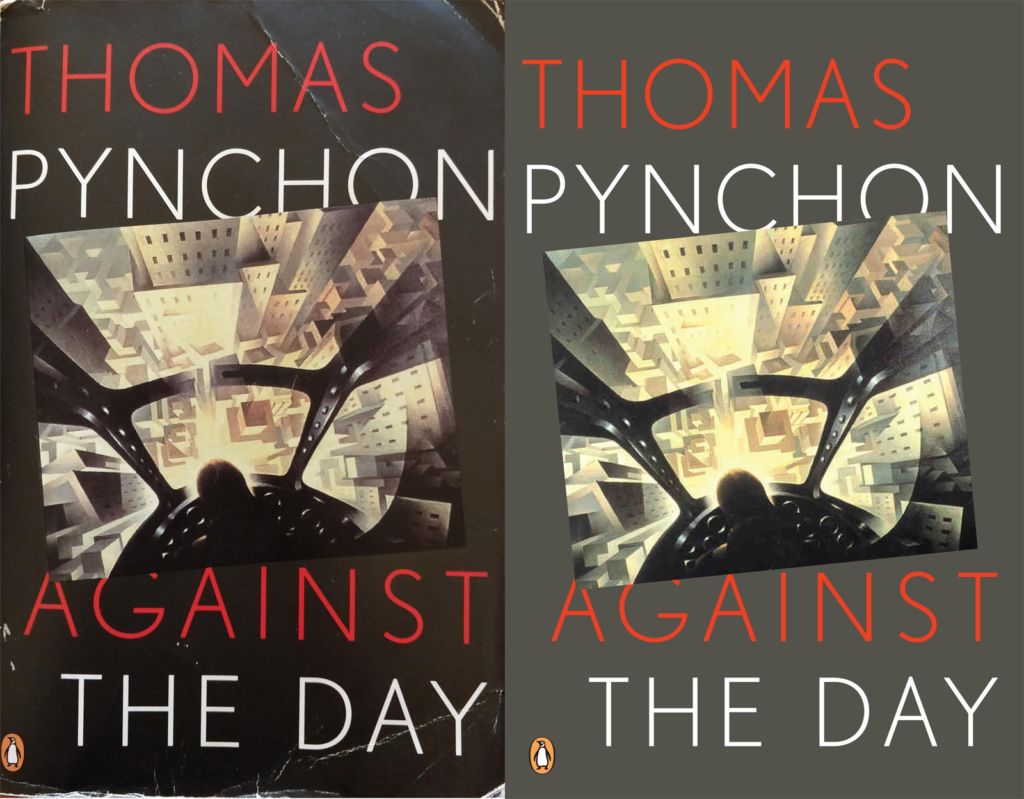
Dentro c’è tanto (e ci mancherebbe, in oltre mille pagine se non c’è ricchezza, di che stiamo parlando?) e il libro è particolarmente orientato a mantenere l’attenzione su una genealogia di stampo totalitario, ma in salsa anglosassone, che unisce, in un passaggio di testimone che avrebbe richiesto ancora quaranta e più anni, l’Impero Britannico agli Stati Uniti. Che detta così, uno si aspetta una specie di saggio palloso mascherato da drammatizzazione con personaggi che, magari, fanno il diplomatico, il giornalista, l’artista. Ma proprio no. Fate conto che il primo capitolo vede l’arrivo di una aeronave, una sorta di dirigibile quindi, con a bordo un equipaggio che corrisponde alla denominazione di Chums of Chance (i «compari del caso»), un gruppo di cinque ragazzi e un cane, di razza non meglio precisata, che ama leggere i classici. È evidente che del realismo non ci si fa un gran problema. A un certo punto, e non voglio farvi passare la voglia (ci sono già tanti motivi per cui potrebbe), c’è pure un attraversamento della Terra, sempre col dirigibile, con un sorvolo su una non meglio specificata fortificazione di esseri che abitano le viscere del pianeta. Il tutto, condito da una direttiva di non interferenza che a qualcuno ricorda tanto quella di Star Trek. Insomma, avete capito il tipo di cazzeggio.
Ma insieme agli exploit più rocamboleschi e assurdi tipo Shambhala e la terra cava ci sono anche i percorsi evolutivi scientifici veri o romanzeschi legati al potere che deriva dalla tecnologia e della conoscenza, dalla caduta della teoria dell’etere luminifero alle peripezie di Tesla, alle lotte degli avversari palindromi Renfrew e Werfner, all’incastonamento di eventi più o meno misteriosi, come quello di Tunguska e il crollo del campanile di San Marco, in scenari di guerra tra società segrete, dotate di mezzi e armi altrettanto imperscrutabili.
I Tool stanno bene accanto a Pynchon, anche solo per il fatto di pubblicare dei bei mattoni a intervalli di tempo ben più che lunghi. 10000 Days arriva cinque anni dopo il precedente Lateralus, lavoro che già, casomai ce ne fosse stato bisogno, sanciva un diritto di cittadinanza nella cerchia più ristretta dei bravi per davvero, e ci consegna undici pezzi con una durata media di sette minuti. [Va notato che, per avere l’album successivo, Fear Inoculum, sarebbero stati necessari altri tredici anni]
Credo di essermi affezionato a queste due opere che, singolarmente non hanno riscosso un plauso plebiscitario – sono piaciute, «ma» i rispettivi autori avevano fatto di meglio, a detta di molti. Non è un problema se Lateralus è il capolavoro dei Tool (potete mettermi la title track e Parabol/Parabola a ripetizione quanto volete. Certi giorni preferirei un black site dove mi sparano Tool a tutto volume cercando di piegarmi. Ovvio che se mi conoscessero potrebbero farmi cedere di bruto mettendo la musicademmerda del caso). Non è un problema se Gravity’s Rainbow lo è di Pynchon. Il fatto è che, per me, su quella metro, in quell’andirivieni sotterraneo, oltre dieci anni fa, con il colletto bianco e lo zaino aziendale, quei due lavori insieme si sono trovati meravigliosamente. La sensazione di ciclicità via via in trasformazione, solo apparentemente mascherata da circolarità, suggerita da entrambe le parti, mi ha accolto in un ritmo in cui potevo difendere solo una parte minoritaria del giorno ma, nondimeno, con successo.
Poi, il tenore della storia è triste, quelli più deboli finiscono per perdere, probabilmente, e non è neppure del tutto chiaro se ci siano dei buoni (un po’ di cattivi, sì, però), ma non si arriva alla fine senza la sensazione di aver fatto un giro su delle montagne russe abbastanza fuori dal comune. La lunghezza del prodotto non è un problema, anzi. Vale per il libro, vale per la musica. Tra i pezzi quello che meglio si abbina, secondo me, è Right in Two.
Silly monkeys
Give them thumbs, they make a club
To beat their brother down
How they’ve survived so misguided is a mystery
Repugnant is a creature who would squander the ability
To lift an eye to heaven, conscious of his fleeting time here
(Maynard James Keenan, Right in Two)
Complessivamente, pure il lavoro dei Tool non nasce certo allegro, anche senza accostarlo alla parabola di Against the Day, dove le prospettive più rosee sono inversamente proporzionali alla plausibilità di quel che viene narrato: i diecimila giorni del titolo sono quelli della durata della malattia, delle sue conseguenze, per meglio dire, della madre di Maynard James Keenan, fino alla di lei dipartita, ricordata in modo più diretto nelle due parti di Wings for Marie, per un totale di circa diciassette minuti tutti dotati di senso e per niente sovrabbondanti – a patto di non avere fretta e non di volere un ritornello radiofonico dopo trenta secondi di pezzo.
Tutti e due gli autori (delle parole) sono accomunati da un rifiuto abbastanza marcato della condizione di star, Pynchon in modo integrale, è più facile parlare con Salinger, Keenan invece si vede di più ma se ne sta parecchio per conto suo, e così i suoi colleghi di band. Poche interviste, poche chiacchiere. Come ha detto un altro che la vede in modo simile, Cormac McCarthy: perché intervistarmi? è già tutto nei miei libri.
E così, senza aver neppure spiegato veramente bene perché, i due oggetti che raccomando, da consumare preferibilmente insieme, visto che sono anche stati pubblicati nello stesso anno, sono:
- Thomas Pynchon, Against the Day, 2006, edizione italiana Einaudi, un fottio di pagine in brossura, anche più dell’edizione Penguin
- Tool, 10000 Days, Volcano Entertainment, 2006
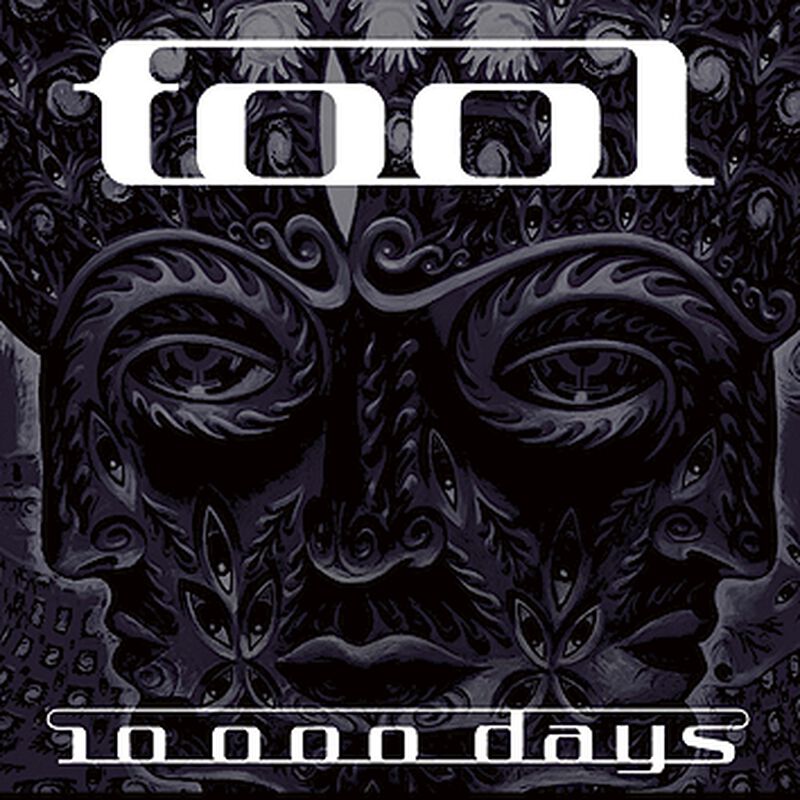
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.