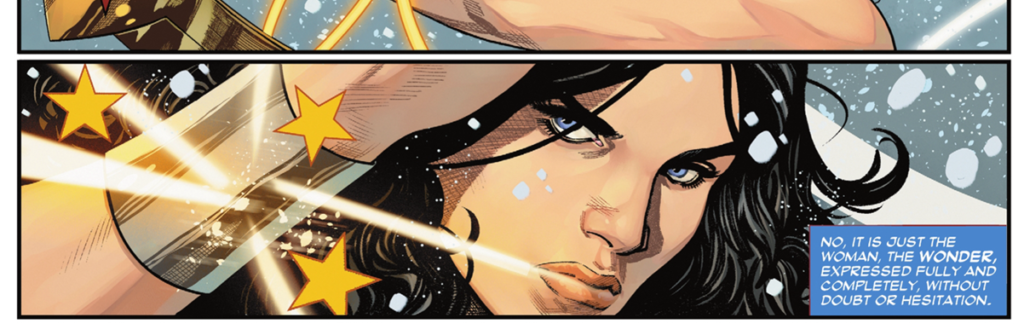di Ivan Hurricane
Marzo 2024.
Pietro Carnelutti, tra i fondatori della rivista “Puzz”, è forse il complice più assiduo nella prima parte della produzione artistica di Max Capa. I suoi lavori compaiono anche su altre iniziative coordinate dallo stesso Capa: su tutte, “Robota Nervoso. Rivista di fantascienza e socialità” e l’albo Il Morto è in tavola, del 1977, uno dei fumetti più sequestrati e discussi di quel periodo.

Quando e come hai conosciuto Max Capa?
A Milano, il 1 maggio 1972, in piazzale Francesco Nullo. Da là si prendeva un pullman doppio che portava a Cuggiono, il paese del cantante Angelo Branduardi. Qui, in un ex ufficio postale delle regie poste, abitava Max Capa. Lo aveva dipinto di rosso scarlatto.
Quel giorno ero lì con un amico per andare al festival di “Re Nudo”a Zerbo, sul Po. Si noti che quelli di “Re Nudo” erano i suoi “nemici”.
Disegnava in un pied-à-terre, privo di servizi: si superavano dei gradini e si entrava nel suo studiolo. Lo conobbi tramite il fratello della sua compagna di allora, Laura Turchet, sorella di Maurizio [Maurizio, detto Mizio,Turchet, disegnatore ricorrente in “Puzz”, Ndr].
Qual è stata la vostra prima collaborazione artistica?
Le prime collaborazioni furono per “Puzz”, quando era in eliografia.

Guardando i vostri lavori di allora, su “Puzz” e su “Robota Nervoso” si ha la percezione che molte di quelle tavole siano state realizzate durante jam session di disegno.
Non si disegnava in gruppo, era il suo assemblaggio che faceva pensare a una jam session.
Abbiamo lavorato insieme solo per Il morto è in tavola [La Salamandra, 1977, Ndr], nell’appartamento con ballatoio presso viale Tunisia, a Milano in zona Garibaldi, dove poi entrarono le B.R. devastandolo ed dandogli fuoco. Lo so perché due mesi prima diedi di bianco all’appartamento, su richiesta di Max, che non poteva pagare un imbianchino.

Il morto in tavola, il famoso libro proibito firmato da Max Capa con lo pseudonimo di Luca Catilina. Ho letto che all’epoca sequestrarono quasi tutte le copie, e che in parte contribuì alla fuga di Max Capa dall’Italia verso Parigi. Come è nato il progetto di realizzare una storia a fumetti sui servizi segreti e gli omicidi politici di quegli anni?
Era la storia del terrorismo in Italia, firmata con lo pseudonimo di Luca Catilina per evitare ritorsioni. Fui chiamato da lui per telefono per disegnare le matite di giudici, brigatisti e protagonisti di quelle vicende partendo dalle foto sui quotidiani, che poi avrebbe ripassato a china. Max si servì di migliaia di ritagli di giornali dai quotidiani e aveva diverse fonti informative, anche oltreoceano, come i gruppi ultraradicali statunitensi. “Puzz” aveva più abbonati lì che in Italia.
Il libro fu sequestrato su tutto il territorio nazionale da Francesco Kossiga, ministro democristiano degli interni e cugino di Enrico Berlinguer. L’editore fallì, nemmeno una copia venduta e cinquanta milioni di allora persi. Nemmeno Max aveva più una copia e la mia, prestata a un amico, non mi fu mai restituita.
Poi, su indicazione della sinistra patinata, uscì un articolo de “L’Espresso” che conservo ancora: «Forse l’autore di questo libro è un animatore della scena underground di Milano», diceva, senza fare il nome. Ma è bastato questo. Arrivarono le B.R. e irruppero nel suo appartamento presso viale Tunisia, un bel caseggiato con terrazze interne a ballatoio sulla corte. Bruciarono l’appartamento, diedero fuoco ai libri e gli puntarono un revolver alla gola: «Non ti ammazziamo perché tutti sanno chi sei, ma tu te ne vai dall’Italia e non torni più». Da allora visse esule a Parigi.

Quali erano i vostri riferimenti artistici? Mi interessa approfondire il contesto culturale in cui vi siete formati e avete iniziato a produrre cose assieme.
Max era un anarchico situazionista, lesse Guy Debord e George Bataille in tenerissima età. Intorno ai sei anni circa padroneggiava già il francese, non è poco per un bimbo nato in campagna. A San Michele al Tagliamento, Latisana vicino al Friuli, parlano friulano infatti, anche se sono in provincia di Venezia
Non credo di aver conosciuto altre persone con quella intelligenza: fece solo il liceo classico, aiutato dalla madre. Le sue posizioni politiche, il suo pensare, mi permisero di scrollarmi dal sinistrismo allora imperante. A Zerbo, dove ancora ci incontrammo, mi apparve quest’uomo con un capello nero e i baffi che mi spiegò tutto. Gli devo moltissimo.
«Lampi di storia sulla preistoria contemporanea», scrisse su un numero di “Puzz”…

Con la supervisione di Max Capa è nato anche un libro a fumetti ora quasi introvabile, Mustfaram, per le edizioni La Salamandra.
Mustfaram nasce da un’idea di Cataldo Dino Meo ma non l’ho fatto da solo [testi di Jonathan e Dino Meo, disegni di Carnelutti, Lorenzo Lepori e Antonio Loconte, Ndr]. È stato realizzato a Milano, a Quarto Oggiaro, nella sua casa che fungeva da piccola redazione. Max stava a Cuggiono, mi chiamò per telefono e poi ci raggiunse.

Max Capa, a detta di molti, era un “alieno” dell’editoria a fumetti: un autore difficile nel segno, eppure anche così magnetico, persino per le nuove generazioni. Qual è il tuo parere sulla sua opera e sull’importanza che ha avuto per il mondo del fumetto?
«Sono troppo povero per fare l’hippie», disse ai suoi inizi. Era figlio di due mezzadri della bassa friulana, i senzaterra. La madre ebbe le doglie sotto un bombardamento di B52 americani su un ponte del Tagliamento sotto il quale si era riparata. È così che nacque Max Capa, nel 1944… e con questi esordi la sua opera risulta immensa, multiforme, inaspettata, da perderci le notti.

Un’altra cosa che mi ha sempre colpito di Max era la sua ossessione per le riviste. Ne ha create tantissime, una più strana dell’altra. Come si approcciava con i suoi tanti collaboratori?
Di riviste ne creò tante e le più strane. Ma non aveva poi tanti collaboratori: “Puzz” lo stampava da solo, nella tipografia a ciclostile di un certo Tiboni [Ugo Tiboni, Ndr], tra viale Tunisia e corso Garibaldi. Io ero lì, presente, faceva quasi tutto da solo.
Nell’ultimo periodo Max si era isolato, viveva lontano dall’Italia e dai contatti con il mondo editoriale, a parte qualche incursione nelle autoproduzioni che lo invitavano. Personalmente, non lo sentivo più dal 2020 quando decise di chiudere i suoi indirizzi email. Com’è stato il suo ultimo periodo?
Il suo ultimo periodo è stato piuttosto triste. Ma mi disse: «Mai lasciarsi andare».
Ha dipinto fino alla morte, probabilmente dentro l’ospedale in cui era ricoverato, e prima ancora dentro la pensione a Parigi in cui risiedeva.
In una delle ultime lettere che mi spedì c’era una sua foto, in bilico su di uno sgabello in una posizione davvero incredibile, mentre dipingeva con una cuffia di lana in testa. Avendo cronicamente pochi fondi, anche per le tele che sono costose, lavorava anche su porte in legno dismesse, preparandole con un fondo apposito, come per le tele.
A parte l’incontro con il pubblico al Leoncavallo di Milano [la seconda edizione del festival AFA, maggio 2017, Ndr] è tornato poche altre volte in Italia negli ultimi quarant’anni. Due volte lo ospitai per motivi di famiglia nella casa dei miei a Udine. In entrambi i casi, mi disse che doveva fuggire via subito poiché i poteri, in Italia, erano gli stessi del tempo del suo esilio forzato. Era in incognito.

Come credi si sia evoluta la sua produzione in tutti questi anni, visto che hai avuto la fortuna di frequentarlo fino all’ultimo?
Ebbe una continua evoluzione. La pittura ad olio giunse per ultima, e dipinse fino alla fine usando colori intensi. Il suo pittore preferito era Vasilij Kandiskij, e non gli piacevano Picasso e Guttuso. Non a caso due comunisti.
Un’altra cosa che mi colpisce molto di Max è il fatto che ogni volta che sento un aneddoto sulla sua vita mi sembra di sentire la storia di un personaggio da film. Ti va di raccontarci alcune delle sue leggendarie “follie”?
Da bambino fabbricava aquiloni.
Nei primissimi anni, io ero alle medie, girava tra i paesini nelle valli del Natisone, in Friuli, guidando un furgone, forse triciclo, con diverse donne a bordo che vendevano per lui calze e biancheria, anche intima, e indumenti vari.
Era un ex paracadutista della Folgore, mi chiamava “salame”, e si sentiva nei modi di fare. Una volta a un festival di musica rock di quattro giorni a Carrara, salì su un pino altissimo, a piedi nudi, scalzo per non scivolare, e arrivò quasi fino in cima, con la forza delle sole braccia. Ma un ramo si ruppe e precipitò davanti a me, sotto i miei occhi. Non respirava quasi più, labbra bianche, occhi chiusi. Chiamai un’ambulanza. Non aveva scarpe, solo un paio di ciabatte da donna. Gli infermieri mi chiesero se potevo procurargliene un paio e così gli diedi i miei stivaletti con tacco alto, erano di gran moda.
Dopo cinque giorni, ricevetti una cartolina: «Nulla di rotto, i tuoi stivaletti mi vanno benissimo!». Quel sempreverde era alto una trentina di metri.