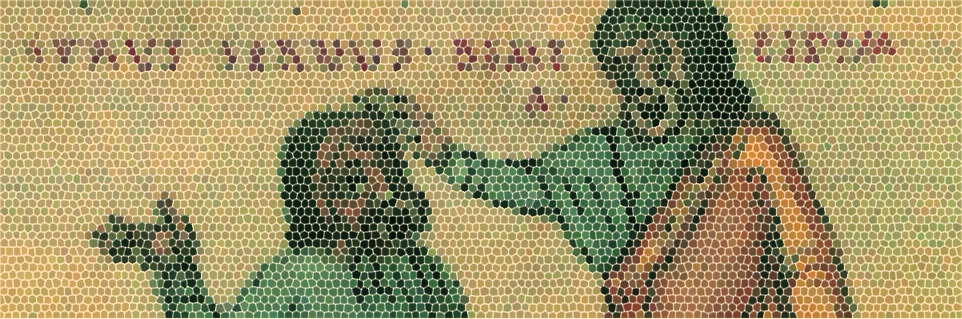Anche se è almeno un quindicennio che non lo faccio, Blade Runner l’ho visto un numero imprecisato di volte, sicuramente inferiore a venti ma non di troppo. Una misura che non ho mai riservato a nessun altro film – per ragioni che probabilmente hanno a che fare con quelle che sembra siano state le impressioni dello stesso P.K. Dick dopo aver visto un montaggio provvisorio di alcune sequenze nel 1981, poco prima dell’uscita dell’opera e poco prima della dipartita dello stesso Dick. La sua valutazione pare sia stata piuttosto netta nel riconoscere al film un valore di effettiva rappresentazione del futuro incombente (in antitesi a un concetto di evasione motivata nell’intrattenimento), con una precisione visuale e una inventiva degni di fregiarsi del merito di avere rivitalizzato un genere un po’ stantio e sofferente come la fantascienza.
Il novembre 2019 è passato da ormai quasi tre anni, giusto prima dell’inizio di questa pandemia ben commisurata allo Zeitgeist, e a Los Angeles non si sono viste macchine volanti e aerostati sopra al Bradbury Building con geishe che invitano a migrare nelle colonie extra-mondo. Uno che scriveva negli anni ’60 aveva tutto il diritto di immaginare una traiettoria spaziale, bisogna ammetterlo. Ma poi non è andata così, non è stato più molto interessante faticare per andare a fare giratine a centinaia di migliaia di chilometri dal pianeta, stipati come sardine, impotenti come astici nell’acquario del ristorante. Ha smesso di essere un valore nel beauty contest globale – perché anche la «corsa allo spazio» altro non era se non la solita trita questione cazzolunghistica (prima io, gnè gnè gnè). E quindi niente astronavi, niente macchine volanti ma anche niente fotografia à la Jordan Cronenweth. Ma questo non toglie che tutto il resto fosse terribilmente azzeccato – come lo stesso Dick non mancò di riconoscere.
Sì, ma i replicanti? Vero, quelli non ci sono, almeno come prodotto, come risultato di un processo industriale. Ma, come ho già ripetuto cento volte, ce l’aveva già detto Fromm in Fuga dalla Libertà che l’essere umano contemporaneo stava diventando qualcosa di molto molto simile a un automa etero-programmato, ancorché volontariamente abdicante a una propria spontaneità. L’invenzione narrativa dei Nexus 6 potremmo vederla come un semplice ribaltamento, una estroversione travestita di una tendenza ormai già conclamata e irrobustita delle vicende della società umana. Lo sappiamo, i replicanti sono migliori, più forti, più intelligenti, più accattivanti, più tutto – anche se, proprio per questo, hanno limitazioni introdotte in sede di progettazione, per far sì che il più umano non sopravanzi l’umano, cosa che, calandosi nel contesto narrativo di Blade Runner (film o libro, è indifferente da questo punto di vista), appare non dico facile a realizzarsi, ma proprio praticamente scontata.

Il sogno del miglioramento del sé misurato nelle prestazioni e nei risultati registrabili in un conto economico, il cammino del soggetto dal basso verso l’alto con un accento sempre presente sull’aumento di rispettabilità e riconoscibilità inestricabilmente allacciate a una nozione di ricchezza materiale, quelle traiettorie tipiche di un legame con quel cristianesimo riformato che ha dato verso e sicumera all’ordine capitalista occidentale di marca anglosassone, diviene, nel ventesimo secolo, una fonte di ansia insostenibile, lo sappiamo bene, probabilmente perché, finalmente, si inizia a non crederci più. Il che appare abbastanza scontato, oggi almeno, anche se quel credo non è stato sostituito da altro quindi continuiamo a recitarne i riti anche se la fede sta a zero, però è veramente notevole guardare a come neppure la Grande Depressione sia stata sufficiente a estirpare il morbo tossico di tutte quelle promesse ammiccanti. E neppure la guerra. Le voci dubitanti già c’erano, lo si sa, ma per spandere il vento gelido della paura sarebbero serviti vari altri decenni.
Nel denoument del film assistiamo all’innalzamento morale e lirico del replicante Roy Batty che si prende tutta la scena e tutto il tempo, lasciando l’umano Deckard a fare da mero, ancorché necessario, uditore – e in questo non posso non leggere un tributo alle traiettorie (non ancora concluse) che citavo sopra. Nel libro i replicanti sono, essenzialmente, degli stronzi bastardi come gli umani, non brillano per slanci ulteriori, ed è probabilmente da questo punto di vista che sono più marcatamente indistinguibili dagli umani. L’atto di misericordia al termine del duello, l’attestazione di un tributo al valore della vita, sono quello che tutti volevamo vedere, smette di piovere e le nubi un po’ si aprono, passa un refolo di speranza, l’umano plus morente viene a dirci che l’essenza dell’umano, proiettata nel suo enhancement tecnologizzato, è più forte di tutto e che c’è ancora una via per l’affermazione di un bene, fatto di misericordia, grazia e perdono. Difatti, a far calare una nota stronza sulla scena è quel mezzo zoppo di Gaff (interpretato da Edward James Olmos, che più di vent’anni dopo giocherà a sua volta un ruolo centrale in un altro caposaldo della fantascienza nelle arti visive) con la sua profezia/minaccia sulla vita residua di Rachel.
Qui ci sarebbe da considerare la questione del director’s cut ma non mi interessa, non oggi.
La questione centrale riguarda proprio il termine «umano». Per poter gestire un comparativo di maggioranza devo sapere da cosa parto e credo che lo stiamo dando un po’ troppo per scontato. Sia quando tacciamo l’umano di incredibili bassezze che quando lo esaltiamo per una presunta superiorità a tutto il resto del creato (uso il termine perché, di nuovo, sono le prospettive religiose a etichettarci come incredibilmente speciali).
E non ci aiuta la semantica, neppure quella di uso comune, perché usiamo in continuazione espressioni come «un trattamento umano» o «condizioni disumane», come se fosse estremamente chiaro cosa intendiamo. Cioè, non che ci sia confusione, ci capiamo quando le usiamo, ma colpisce in modo profondo questa polarità manichea umano-disumano. Tocca ricordarci di Terenzio, temo – niente di umano mi è alieno, e come se fosse una disuguaglianza perfetta, l’umano non può in alcun modo mai essere disumano (lo dice pure il gobbo duca di Gloucester…). Tutto quello che fa viene iscritto nel ruolino di marcia, nel tableau de bord, nel curriculum vitae della sua specie.
Pol Pot era umano, no? Se mi chiedi un trattamento umano e mi ispiro a Pol Pot possiamo dire che il malinteso è solo colpa mia? Quando diciamo umano stiamo dicendo buono, come diciamo tutte le volte, come scimpanzé litigiosi, che buoni sono tutti quelli del mio gruppo, se e quando li considero in opposizione alla tribù degli altri. Quando non ci sono gli altri, invece, tra i miei ho nemici giurati e sono pronto a far loro la pelle. L’amore per i propri simili è funzione diretta del contesto, c’è poco da fare.

Quando la declinazione superomistica del mondo tecnologizzato e disperato che immagina Dick (e in questo il suo lavoro è sempre stato di realismo futurista) inizia a intravedere non più un traballante mostro di Frankenstein rappezzato e rianimato dall’energia elettrica ma pur sempre identificabile come una pantomima della vitalità ma un superamento in termini prestazionali e qualitativi, la depressione non può che sfociare in violenza e l’operazione tribale non può che diventare una demonizzazione. Troppo umano diviene repellente, non già in sé, ma in relazione alla nuda pochezza dell’umano originario che nella propria originalità non trova forza sufficiente da poter giustificare una sopravvivenza (tema che quell’altra opera con Olmos riprenderà con forza).
L’umanità come fatto biologico non costituisce una patente di sopravvivenza. L’avevano capito i tycoon della Gilded Age, lo sanno quelli di quest’epoca. È stato più faticoso vestire di un corredo di diritti l’individuo esistente di quanto lo sarà (ed è) spogliarlo, talvolta con la sua entusiastica collaborazione.
Oggi, la cosiddetta intelligenza artificiale si esprime su un piano di non comparabilità delle prestazioni. Fa cose incredibili, ma di solito dal punto di vista computazionale, non di sottigliezza di ragionamento. Forse non siamo neppure vicini a quella soglia, non so bene cosa potremmo aspettarci. Ed è questa incertezza la porta a cui bussa Blade Runner quando lo guardiamo, anche nell’insinuazione che Deckard stesso sia un replicante. Ma se l’umanità e la più-che-umanità sono virtualmente indistinguibili, sono veramente due livelli diversi? Non sarà che, in nome di un terrore per la varianza in generale, il termine umano vuole giocare il ruolo di una dichiarazione di conformità?
Da questo punto di vista il terrore vero degli umani allora diventa quello di essere superati – in questo caso da una vera e propria generazione di prodotto. Di essere resi obsoleti, trapassati, inutili. Un’ansia di morte espressa nella proiezione di un sé migliore ma anche estraneo, non consanguineo, prometeico, quasi maledetto.
Non stupisce che, nella profonda e realistica coerenza dei personaggi dickiani, i replicanti siano odiati e osteggiati a tal punto. La dimensione del potere, che nel mondo capitalistico moderno, è un mostro ad almeno due teste, quella più prettamente politica e quella economica, complica il quadro – perché le redini del gioco appaiono più saldamente in mano alla corporation di turno che a soggetti dell’ordine cosiddetto democratico.
Nel mondo che viviamo, destituito della solenne grandiosità delle megalopoli del cyberpunk (tutte modellate su quella Los Angeles del novembre 2019 – aveva ragione Dick a riconoscere che gli autori del film stavano creando qualcosa di nuovo, di autonomo), permangono e prosperano gli elementi che generano e amplificano questo fenomeno della replicanza, dell’umano aumentato sovrapposto a un umano di base, dato per scontato. Non abbiamo il viaggio interstellare o interplanetario, ma stiamo vivendo da un bel po’ in un mondo che pare quello di Palmer Eldritch, con biechi imprenditori presi in guerre commerciali spietate, con l’unico scopo di venderci i loro giochini supportati da droghe ancillari e un pubblico che ne ha bisogno per evadere dalla bruta, piatta, ottusa insensatezza della propria faticosa esistenza.
È un momento opportuno per svegliarci da quel senso di pennichella in cui siamo rimasti per i molti decenni del secondo dopoguerra, facendo la tara, una grossa tara, a quel concetto di umano. Non che siano mancate le occasioni per ragionarci su ma non ce n’è mai fregato veramente molto – che ne so, le carestie e i massacri nel continente africano, per citare un tema. Li abbiamo ascritti a un generale «questi subumani», lo sapete bene, anche se non vi piace riconoscerlo.
Quel che supera l’umano resta sempre umano. Non ci sono vie di fuga. Un esempio? Quando Dante se ne va a «trasumanar» in Paradiso ci siamo già rotti i coglioni, e non parlo solo degli studenti più riottosi. Ci piace l’Inferno e apprezziamo i momenti più violenti del Purgatorio. Il resto ci annoia mortalmente. La strada per il torture porn e lo splatter non è lunghissima.

Vabbe’, in quest’angolo di non-competenza (o almeno, di non-specificità e di assenza di qualsivoglia abilitazione o riconoscimento da parte di ordini o albi professionali) si finisce sempre per maneggiare un po’ malamente temi che, usualmente, meritano saggi chilometrici e raccolte di detti e aforismi maturati lungo un’intera vita. Ma non ho tutto quel tempo quindi questo è quel che passa il convento.
I replicanti più umani ci piacciono anche se ci spaventano, perché prendono quello che abbiamo sempre desiderato fare e lo fanno. La rivolta contro l’oppressione del dover morire si manifesta così nel parricidio, nell’uccisione dell’interrogante nel bel mezzo del colloquio di lavoro, nel perseguimento dei propri scopi con la leva della forza, sotto una impunità alimentata a colpi di intelligenza e spregiudicatezza, nella manipolazione dei più deboli (il povero J.F. Sebastian).
Humani nihil mihi alienum puto. È una dichiarazione d’intenti – l’uomo nuovo potrà anche essere meno genuino (lo si fabbrica) ma, a meno di non tenerlo ingabbiato, imprigionato, schiavizzato in una gabbia di mortalità ancora peggiore di quella che tocca ai genuini, è un vincitore che usa armi umane. Non è che gli siano stati dati superpoteri. È solo più forte.
Non so cosa accada in altre potenziali società tecnologizzate, altrove. Qui, in questa, la fantasia masochistica dell’essere dominati da un progenie più forte ma un po’ aliena sembra essere uno spunto per dare forza e dignità a una genealogia che, evidentemente, non riesce a trovare argomenti migliori. Il più umano diviene un punitore e un boia ma, come tutti i boia, non può essere fatto vivere nel gruppo sociale senza un qualche stigma irrimediabile. Intanto le sorti progressive dell’umanità, non solo nella fantascienza, sembrano prendere forma, in modo quasi necessario, intorno a un concetto esteso di ibridazione con il tecnologico, a livello di hardware fisico, ma senza particolari slanci filosofici, come se fosse un mero opportunismo. L’umano del futuro incombente sembra essere un soggetto non più intelligente, non più forte, al quale vengono offerte soluzioni di automazione che, a ben vedere, sono largamente rinunciabili o, se pure promettenti, richiedono di essere alimentate e seguite, dal momento che introducono un onere di controllo non banale (la domotica, per esempio). Per diventare «migliore», se non è la macchina che ti entra dentro, sei tu che devi starle dietro. E anche questo, spesso, costituisce già una punizione abbastanza cocente, per una hybris che non era neppure proprio la tua. Almeno fino a che la macchina non avrà più bisogno di te per sentire il bisogno di decidere e di provare il gusto di farlo.
[C’entra e non c’entra, ma di sicuro è umano: la commedia di Terenzio che, senza particolari slanci di fantasia del sottoscritto, presta il titolo al pezzo di oggi, riprende un’opera di Menandro e quindi sono almeno duemilatrecento anni che la vediamo in un certo modo su certe cose. Menedemo, il protagonista, si autopunisce in ragione del rimorso che prova per aver impedito le nozze del figlio con una ragazza di miseri mezzi ma, dopo una serie appropriatamente lunga di peripezie, tutto finisce bene, tranne che per Bacchide, la cortigiana amata dal Clitifone, figlio del vicino di Menedemo, Cremete (lo so, sembra uno scioglilingua). Cremete costringe il figlio a rinunciare all’amore di Bacchide, facendogli promettere che sceglierà come sposa una femmina più raccomandabile.
Ricorrendo a un altro titolo di opera teatrale, un po’ più recente: ‘tis pity she’s a whore. Non siamo mai cambiati.]
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.