«[…] i tanti sono uno anche se appaiono
moltiplicati dagli specchi. Il male
è che l’uccello preso nel paretaio
non sa se lui sia lui o uno dei troppi
suoi duplicati.»
Il bello della citazione di Montale da Satura è che funziona anche al contrario: quando pensi di essere sicuro di essere stato tu proprio tu non è affatto detto che sia così, proprio per niente. O, pure, non c’è il paretaio, non c’è la prigione ma solo le ventidue e dieci di giorno feriale dopo aver cenato in fretta. E cosa dovrebbero dire poi gli altri troppi duplicati? Non avranno anche loro un analogo del diritto di parola? Chi è che parla quando dice «io»?
Lo schema qui, miei cari non-lettori, ormai è cristallizzato come quello del manzai giapponese: ci sono quello serio e quello ridicolo, i fatti del mondo, della storia, dell’arte, dell’esistere, e c’è il bassista dopolavorista da salotto, paradigma convincente di avversione al rischio e irrilevanza totale, che è anche quello che dà fiato al fantoccio apparentemente serio, quello che sembra sapere qualcosa di qualcosa e affronta quei lunghi preamboli che riesce sempre, in qualche modo, ad agganciare alla dimensione di I.B.N. S.L.I.N. (Il Bassista Non Se Lo Incula Nessuno, naturalmente). Ma poi si scopre che non è un manzai, ma un rakugo ubriaco dove l’intrattenitore si dimentica di essere da solo e tratta le sue voci come compagni di scena. La messa in scena si fa così confusa e ci perdiamo, non sappiamo più se siamo in un vaudeville o al teatro tragico. O tutt’e due.

Ecco, la pratica e lo studio della musica somigliano molto, tra le varie cose a cui somigliano, ad un simile teatro – ci entri pensando di divertirti ma poi non va esattamente così, però il biglietto l’hai pagato e insomma pare brutto andarsene e farla finita lì, a tratti pare pure quasi divertente, e quindi ci resti. Oltretutto fuori non è Broadway, non è il West End, non ci sono molti altri posti in cui andare, quindi DEVI restare (ricordati che domani alle 6:30 suona la sveglia e ti aspettano le solite dodici ore di lavoro – quelle che sarebbero otto ma che, per strani fenomeni relativistici, diventano sistematicamente dodici, panino strozzato incluso). Le domande sull’identità di solito non corrispondono con l’armamentario mentale dell’idealtipo del bassista. Non se lo incula nessuno anche perché sta parecchio per conto suo, e se fa casino è perché si comporta da pazzo scriteriato, mica ti ci mette lo spiegone e ti racconta i fatti suoi. In breve, non sai come sta il bassista, ma non ti serve e vai avanti. C’è il cantante per ‘ste cose, per le crisi, quella roba lì è il suo strumento, non il tuo – ti fa pure male avere dubbi, andare a tempo e non perdersi sulla struttura è una questione di certezze. Se il bassista è un po’ star vuol dire che è bravo a sufficienza da poterlo essere, il che accresce ancora di più l’insondabilità della sua solitudine nella terra di nessuno tra il «mondo libero» della voce e della chitarra e il Patto di Varsavia col batterista. Sennò se ne sta buono e basta, cerca di non creare turbamenti di sorta.

Evocare una inospitalità da terra di mezzo berlinese d’antan può essere utile per rimarcare il fatto che quelli bravi sono bravi perché ci si muovono bene in questa città di trame nell’ombra. Il bassista dopolavorista da salotto invece è come un fagiano sotto Xanax il giorno dell’apertura della caccia. Sto dicendo ancora una volta che questo strumento è più difficile e più ingrato? Mah, forse sì, però è il mio e ci sono affezionato, non potrei andarmene. Cioè, ho in un angolo una Stratocaster, che attaccata a un Guitar Rig ti fa divertire come uno scemo, però va bene così, perché, a sua volta, una chitarra da studiare e conoscere davvero sarebbe un altro «mostro» al centro di un suo labirinto con tutte le relative aspettative di sacrificio. Ho già il basso.
Ah, c’è anche una master keyboard a ottantotto tasti pesati, accucciata sotto il letto, pronta a mordere con le sue fauci di squalo dai denti cariati. Ma questa è un’altra (pericolosa) deviazione.
Quello di cui sto parlando accade essenzialmente nei live ma, visto il periodo, vista la pratica da salotto, la possibilità di trovarcisi è veramente bassa. Quindi resta la condizione quasi-solipsistica (se si considera la platea involontaria composta da coniuge, figli, animali domestici, vicini al di là del muro) di quando si suona da soli e, porca miseria, viene fuori il suono, viene fuori il groove, la scioltezza, la velocità e l’incisività che pare qualcun altro a suonare. Voglio dire, qualcuno che non sembra avere molto a che fare con il tizio che suda, sbuffa, perennemente scomodo su note troppo diseguali che dovrebbero invece suonare come cariatidi marmoree a sostegno del pezzo. Quel tizio che sono io, che sei tu, a cui si inceppano le dita, che qualcosa si perde per strada anche quando l’ha suonata «benino», il tizio che deve un po’ accontentarsi, perché non arriva alla soglia oltre la quale si valuta il suono, l’interpretazione – perché materialmente ha sbagliato questo o quello, perché siamo ancora a prima. Quando entra in gioco l’altro, o uno degli altri, e perché, è qualcosa di più ignoto e insondabile di un mistero eleusino – e, oltretutto, se una volta bevuto il ciceone ti fai delle domande, appena l’ombra di una domanda, l’effetto scompare, la sincronia si sbriciola, il flusso si interrompe e prosciuga. E resti lì come uno scemo ad attraversare le strettezze di tutto il pezzo.
Che non vuole dire che il pezzo sia difficile – macché. Magari è The Passenger di Iggy Pop ma se l’altro non ci si ritrova, in quel ritmo sempre uguale, uguale, uguale, dall’inizio alla fine, l’esperienza che ne deriva è solo spiacevole. Resti tu a fare bum-bu-bum-bum sugli stessi quattro accordi per cinque minuti, come un orso ballerino in ciabatte. L’insidiosità delle cose «facili».
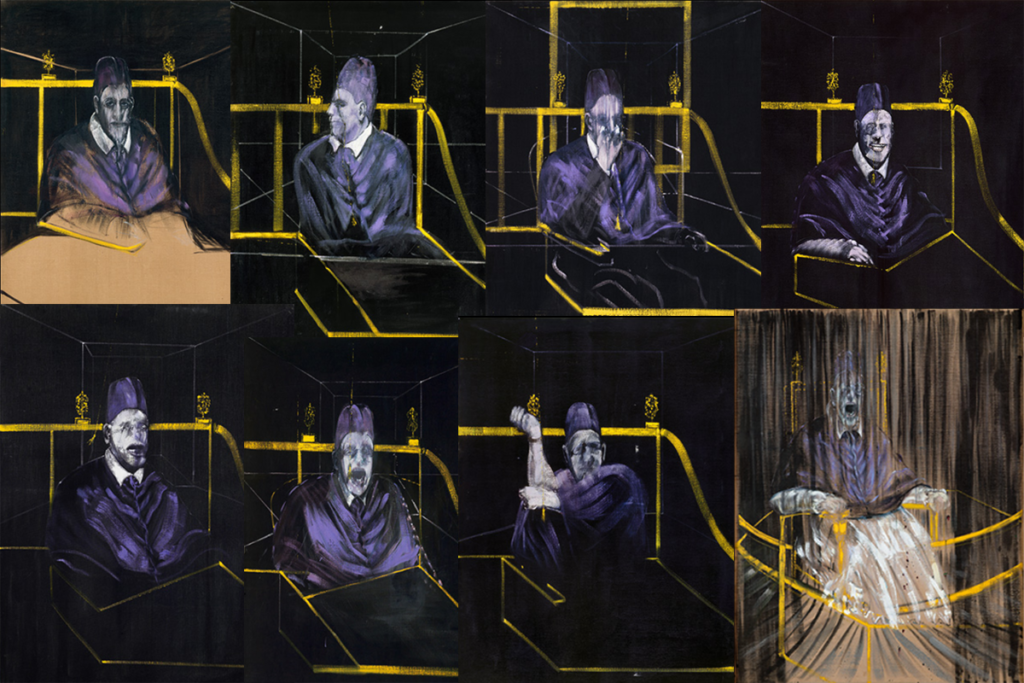
E questo, a sua volta, non vuole certo dire che quelle difficili siano una benedizione. Intanto sono difficili. Poi non è detto che siano belle solo perché sono difficili. Ho conosciuto tanta gente che sembrava voler essere migliore perché faceva le cose difficili, perché le faceva sembrare facili, o forse erano i miei occhi invidiosi a vedere in quello sforzo la vanità di chi puntella la propria immagine, la rinforza con il vantage point di una posizione non facilmente raggiungibile. Forse c’era un vissuto caldo, sincero in quei virtuosismi, chissà. Forse dobbiamo fermarci a quel che dicono a chi ascolta [a questo proposito ci sta tutta che i Vulfpeck a te facciano schifo e a me facciano sognare di riuscire a suonare il basso in quel modo].
Forse non dovremmo parlarci o conoscerci troppo quando si suona insieme. Nella musica dell’orchestra classica non puoi immaginare centoventi orchestrali che si amano, o anche solo conoscono, vicendevolmente: considerando anche il direttore sono settemiladuecentosessanta potenziali linee di comunicazione. Ti immagini il casino se dovessero mettersi tutti d’accordo negoziando? E col triangolista chi mai ci vorrà parlare?
Ognuno suona solo. In mezzo la musica agisce da linguaggio, un linguaggio a sua volta altro rispetto a quello parlato, del tutto indipendente, almeno potenzialmente. Certo, quando si suona bene con qualcuno e si è in contesti meno paludati non è mai un caso: al suonare bene (anche solo soggettivamente «bene», sia chiaro) insieme si accompagna anche qualche rispondenza in termini di punti di vista sull’esistere e sul senso del fare rumore organizzato insieme.
Però ora sto rischiando di finire fuori rotta – non si tratta degli «altri fuori» oggi, ma di quelli dentro. L’idea che ci sia dentro di noi uno più bravo è solo una corruttela colloquiale di tappe ormai consolidate negli studi sulla mente e sulla personalità: la molteplicità non è più uno spauracchio, l’unità monolitica un mito ormai infranto. Che sia un coacervo di voci a competere dentro di noi per occupare un baricentro non deve più sorprendere, eppure viviamo e lavoriamo sotto il tacito presupposto di non affrontare mai esplicitamente l’argomento. E quindi ecco le descrizioni curriculari delle proprie capacità, dei conseguimenti, del questo e quello, dell’io che è fatto comme çi e comme ça, noto, evidente, performante – ma a chi, tra gli uccelli presi nel paretaio, si possono ascrivere questi tratti e queste imprese, ammesso che corrispondano a qualcosa di oggettivo (e già dimostrarlo configura un’impresa di non lieve portata)?
Ecco, la musica mente molto meno di altro, si tratta solo di cedere un po’ del controllo, dal centro (presupposto tale, sia chiaro) a qualche parte in periferia. Smorzare il linguaggio delle parole, la litania continua della formulazione di teorie inconsistenti che hanno l’unico scopo di mantenere «curricularizzata» la narrativa della vita, centrata, tutta inquadrata nel cono di luce del faretto alogeno della paura di scoprire, appunto, «altro». Allora, così, ho capito che quelli che sulla musica ci si sono centrati combattono lì la battaglia della presentabilità complessiva del loro esistere, una partita resa assai più complicata di quelle in altri campi dal fatto che con la musica è parecchio più complicato barare – gli irregolari come me, invece, hanno il privilegio di poter utilizzare questo ambito in modo più irresponsabile, più protetto, per trovare quel che può venirne fuori, fosse anche poco o niente. Un privilegio notevole, non c’è che dire. E massima stima ai professionisti della musica, condannati a tenere acceso il fuoco da vestale dello studio pratico. Altro che dannazione faustiana, la pena viene scontata contestualmente al resto in via anticipata, senza garanzia di piaceri da patto mefistofelico.

Nella tua dimensione di closet-musicante, nella ripetizione, pure se con mille interruzioni, trovi il valore, via via che i pattern si trasformano in comprensione e memoria muscolare, progredisci un po’, ti fai più corpo e meno mente e quell’«altro» dentro di te che sembra saper suonare fa capolino più spesso. Constatarlo apporta un godimento transitorio (ma quale non lo è?) del tutto aureo, inattaccabile dagli acidi e dalle basi del vivere contemporaneo, basta solo essere disposti a corrispondere, a titolo di caparra non restituibile, la disponibilità a sostenere certi interrogativi. Del genere «forse ho sbagliato qualcosa» o «è questo il ruolo che volevi vivere?» (cit. Ian Curtis). Ma siamo animali adattabili e costruiamo identità surrogate alla velocità del pensiero. Dunque, non meravigliamoci per la quantità di cinquantenni che si possono trovare nei saggi di fine corso delle scuole di musica. Stanno solo esorcizzando le termiti corrosive dei dubbi più vertiginosi.
Hodie mihi, tibi cras.
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.



