Il T.S. Eliot che preferisco, anzi, meglio, l’unico che conosco, è quello di prima dei Quattro Quartetti. Non mi sono mai spinto oltre – probabilmente per non incontrare troppo del conservatore «anglo-cattolico» [sic], del convertito un po’ retrivo, del «sistemato» alla Faber & Faber. È sempre un brutto affare quando finisci troppo dentro la biografia dei tuoi autori preferiti. Comunque, il T.S. che tira fuori la roba detta bene, ma anche male però sincera, e quindi utile, è, secondo me, quello nevrotico, nevrotizzato, impiegato dei Lloyds, che sifona via dall’alienazione personale e da quella dell’epoca The Waste Land. E ci si ferma qui, perché altrimenti dovremmo passare troppo tempo in compagnia del misogino, dell’irrisolto, del passivo-aggressivo (?) che finisce per sfuggire la moglie con evidenti problemi di salute fisica e mentale, fino al punto di farla (?) rinchiudere in una clinica psichiatrica senza mai più andare a trovarla fino alla di lei morte. La voce di Vivienne Haigh-Wood non è stata una voce fortunata: anche dopo la morte di Eliot è finita ulteriormente soppressa e soffocata dal fatto che i diritti d’autore sul suo diario sono andati all’ultima moglie di Eliot, Valerie, la quale non ha, come dire, sollecitamente proceduto a dare alle stampe una edizione critica.
Troppi punti interrogativi, si rischia di schierarsi in un ordine di battaglia inutile (la stessa Virginia Woolf aveva definito Vivienne una «bag of ferrets around Tom’s neck», chissà quali sono le verità vere verissime di come quelle persone si sono sperdute e ferite a vicenda…). Ma noi siamo cinici, si vuole il prodotto e quello che conta è che il nostro autore fosse bello carico di infelicità, di straniamento, di tutti i mezzi di contrasto in grado di evidenziare i mali essenziali del vivere moderno. The Waste Land, come rilevava quell’altro smarmittato senza speranza di Ezra Pound, esce come «il più lungo poema moderno in lingua inglese» e non è esattamente un parlarsi addosso – se si riesce a resistere (già al verso dodici c’è Marie, l’aristocratica russa, no, lituana, che parla in tedesco, tanto per dare un’idea del casino che si incontra) si trova più uno stare male organizzato e spettinato, ancorché coreografato, un coacervo di pezzetti, di scorie in formato keepsake, rimesse insieme sulla spinta di una esigenza che appare essenziale ma anche per piacere e piacersi – l’intellettualismo, l’erudizione, il preziosismo, tutto l’armamentario che finisce per generare la necessità di un apparato critico pesantissimo, le chiose insopportabili (tipo quella sul tordo eremita, citato nell’opera, di cui Eliot ci viene a dire il nome scientifico facendo però un gran casino con la nomenclatura, forse se la inventa, forse quella che indica è caduta in disuso – in ogni caso uno sforzo inutile e posticcio). Se non si rimane comprensibilmente scoglionati da tutta la prosopopea, dalle voci inspiegate, dall’onomastica esoterica, dalla fatica di sfogliare (vabbe’) Wikipedia, azionando i tergicristalli si vedrà chiaramente un incedere quasi dantesco, un descensus ad inferos ma senza riuscita a riveder le stelle. Un cugino di Heart of Darkness (il legame con Conrad non è escursionistico, basta vedere l’epigrafe di The Hollow Men) zeppo di aforismatica siderale e citazionismo visceral-mitologico.
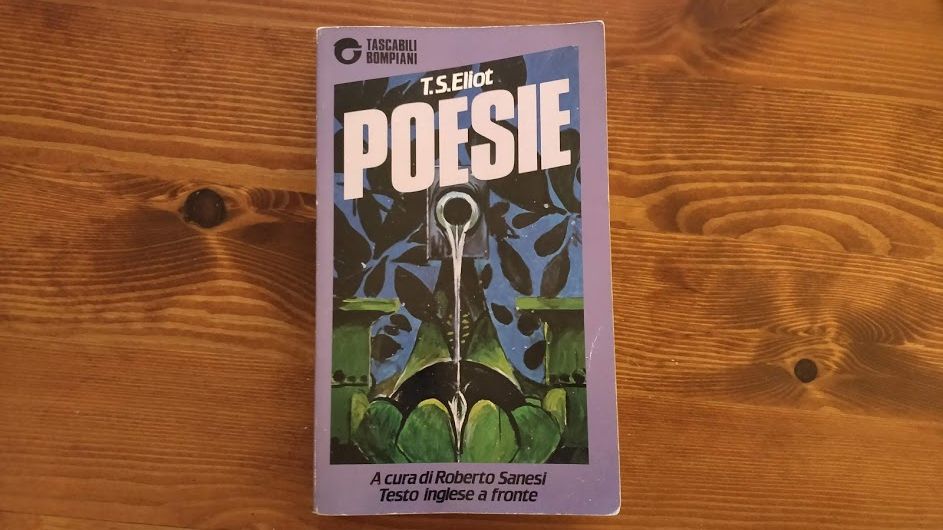
Un poema tragico ma anche tragicomico, grottesco, sardonico (Dante non a caso garbava a Eliot). Si parte con un’epigrafe dal Satyricon, che, non bisogna pensarci troppo, dà subito un’impronta, no? Quel cazzone di Trimalchione afferma di aver visto la famosa Sibilla, a Cuma, sospesa in un’ampolla (e che formato aveva? Una Tinker Bell di disneyana memoria?), tormentata dai ragazzini che le chiedevano cosa volesse. E quella: «voglio morire». Seguono diciannove pagine diciannove di versi. Verso la fine, dopo un mischione eroico di epica e trivialità, di cultura, erudizione, Zeitgeist e frattagliame vario di mito e quotidianità, dopo veramente tanti spunti che vanno giù come punture lombari nella coscienza di chi legge, giusto a quattro versi dalla fine ecco che arriva:
“Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine”
L’idea romantica è quella che, nel mondo dello sgretolamento, raccogliere i pezzetti, i frammenti dispersi e usarli per puntellare la baracca dell’io, dell’identità e della memoria, possa essere, in qualche modo, un approccio, se non alla salvezza, almeno all’affermazione di sé, forse alla rivincita – alla vendetta, addirittura. Difatti la chiusa dell’opera, prima dei saluti in sanscrito è:
“Why then Ile fit you. Hieronymo’s mad againe” (“Bene allora, v’accomodo io. Hieronymo è pazzo di nuovo”)
Qui Eliot ha preso The Spanish Tragedy di Thomas Kyd, l’archetipo della tragedia elisabettiana dove muoiono tutti (Tarantino un s’è inventato nulla), eroe incluso, nel contesto di una storia di intrigo, finzione (Hieronymo non è veramente pazzo quando sembra che lo sia) e vendetta. Sono le ultime parole in inglese, prima delle sei in sanscrito che chiudono, serenamente, anche se con tanto (ovviamente) distacco culturale, il soffertissimo excursus.
La suggestione dei «frammenti» su cui punti tutto, una stabilità di compromesso, un sollievo dall’affanno continuo, la raccolta delle energie per rilanciare l’ambizione di rivalsa, nonostante che quanto stiamo puntellando siano «rovine». Ecco, tutto questo probabilmente è appannaggio di soggetti le cui condizioni trovano una o più collocazioni specifiche nel DSM V, ma, nondimeno, sono sicuro che fa riecheggiare sensazioni simili in tanti, senza scomodare concetti di psicopatologia: se il mondo e la società degli umani fossero, o apparissero, almeno, un luogo confortevole, perfettamente «naturale», armonioso, bilanciato seppur irrimediabilmente impermanente, non proveremmo questa trazione inevitabile verso la collezione, la raccolta, il puntellamento.
Così, da Eliot credo di avere imparato l’importanza primaria di costruire una costellazione, una ragnatela di riferimenti in cui abitare, ciascuno con il proprio patrimonio di pezzetti. Libri, poesie, film, brani musicali, nozioni, immagini, racconti, però rigorosamente non in edizione critica ma rimasticati e metabolizzati dalle convoluzioni corticali di ognuno. Balliamo, al vento, abbarbicati a queste strutture filiformi, la cui solidità, però, è direttamente proporzionale alla nostra curiosità o alla nostra follia. In ultimo, non credo che «accomoderemo» nessuno, Hieronymo gioca con le parole ma le sue (i.e. nostre) chance di vendetta, nel mondo fuori dalla Spanish Tragedy sono pari a zero. È più una convinzione di avere affermato qualcosa davanti a un pubblico, per quanto ristretto. Pubblico tendente a uno, in tanti casi (o zero, se non si considera il soggetto affermante).

Se si tratti di malattia sociale o resistenza attiva allo sperdimento esistenziale non saprei dirlo in assoluto. Di certo la vita affettiva di molti di noi si alimenta di queste briciole, anche se alla fine non compongono un quadro, non mettono insieme un racconto, non sanciscono alcuna revanche, non puntellano neppure a sufficienza e si affoga, sistematicamente, nel risveglio. La musica offre uno shot di elisir trasformativo, liberandoci dalla schiavitù della parola. Mentre tutto avanza nella crescente entropia, intrattenersi con la bellezza di quei passaggi, di quelle parti che tenti di riuscire a suonare decentemente sul tuo strumento (quindi maltrattandoli un po’, perché non li rifai mai così belli come potrebbero essere), non salva il mondo, non sposta niente, forse addirittura sottrae tempo ed energie a buoni propositi e degne iniziative, ma raccoglie e compone le rovine personali in un modo a cui non potrei più rinunciare.
Opus minimum.
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.


