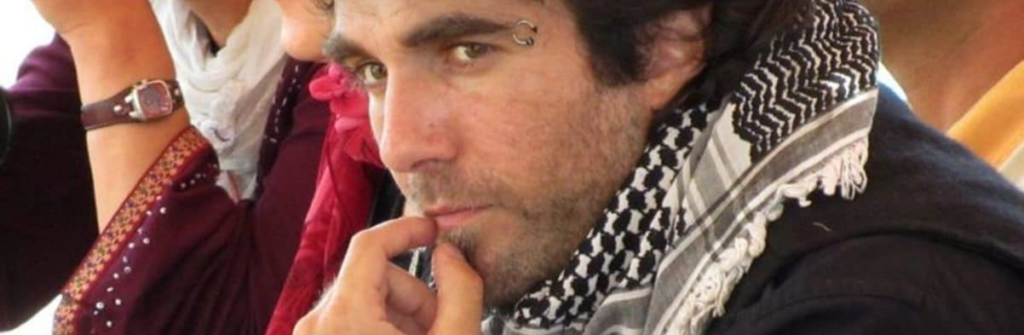Per la tredicesima prima volta (non ci si abitua mai, non io almeno, è un esordio continuo) di questa rubrica ci si trova a incrociare il tema della settimana, stavolta quello apparentemente autoevidente della perdita di umanità, anzi no, di acquisto della disumanità, intesa come destinazione di un cambiamento, non si sa se in meglio o in peggio o al di là del bene e del male. Ma sarà proprio così, si può cambiare e andare oltre?
No beast so fierce but knows some touch of pity.
But I know none, and therefore am no beast.
(Shakespeare, Richard III)
Mi sono imbattuto in questi versi guardando, probabilmente su TMC, il film A 30 Secondi dalla Fine (Runaway Train), un prodotto per molti aspetti particolare, secondo film americano di Andreij Končalovskij, basato su una sceneggiatura di Akira Kurosawa, con un cast che comprendeva Jon Voight (padre di Angelina Jolie e fine pensatore che ha comparato Biden a Satana), Rebecca de Mornay (attrice niente male e fidanzata di Leonard Cohen a un certo punto), Eric Roberts (fratello un po’ sfigato di Julia) e i due debuttanti Danny Trejo (ovvero Machete, cuginetto di Robert Rodriguez) e Tommy «Tiny» Lister (wrestler, caratterista, cristiano born-again e vittima recente del coronavirus – 10 dicembre). Aggiungiamoci Edward Bunker come sceneggiatore E attore e abbiamo una compagine di tutto rispetto di notevolissimi svalvolati e detonati presenti e/o futuri, a maggioranza cristicolo-nazionalista sotto la direzione di un regista sovietico. [Tra l’altro il primo film in cui compare Bunker è Straight Time, tratto dal suo romanzo No Beast so Fierce, guarda un po’ che coincidenza]
Che dietro a una storia confezionata con personaggi, codici e scenari americani ci sia la mano e la testa di Kurosawa resta evidente. Non che manchino elementi di redenzione, di vittoria e rivalsa, di distinzione tra l’umano spietato (ma rispettato e temuto, il direttore Ranken) e quello dotato di pietas (benché reietto, il galeotto Manny), però alla fine non c’è il bene, non c’è il male, solo una concatenazione ineluttabile nella quale dominano la sensazione di perdita di controllo e la certezza che non potrà finire bene. E che il punto di partenza è una prigionia alla quale non si può comunque voler tornare. Per fortuna, almeno per l’economia della storia, la narrazione si alimenta della lotta tra i due modelli internamente contraddittori del galeotto-bestia (quindi pietoso) e del direttore-umano (quindi spietato).
A questo punto scoperchiamo il nòcciolo del reattore delle analogie e disperdiamo radioattività metaforica.

Il bassista da salotto non è Manny e non ha Ranken da affrontare ma il percorso da un paradigma di prigionia e corvée a quello di rivalsa autodistruttiva è troppo rappresentativo per non considerarlo una ghiotta opportunità per banali, prevedibili parallelismi. Spoilerando senza pietà, il Runaway Train non può fuggire veramente, ci sarà chi si ferma e chi no, e questi ultimi sono destinati al binario morto, affrontato a tutta velocità. Ci sono tutti gli elementi del dramma, interiore e materiale. Oppressione, fuga, devianza, ineluttabile schianto. Anche perché, per riuscire nella fuga, non sarebbe male avere una direzione, una rotta, ma, nelle nostre condizioni, non è semplice averne una – alcuni di noi optano per un approccio gourmand da collezionisti di strumenti o confezionatori di video da quarantacinque secondi con il passaggio o solo di quel pezzo e del tal altro. Anche per quello ci vuole tempo, e una quantità non banale di capacità effettive – elementi nient’affatto scontati, insieme a una tenacia e a una continuità non indifferenti, specie oggi nell’epoca del panopticon dei social. Per me, e quelli come me, la dimensione resta più privata, non si va oltre il salotto ed è un problema orientarsi nella landa ghiacciata dei corsi online attivati, degli spartiti accumulati, dei pezzi che si vorrebbe tirare giù a orecchio, di quelli che stiamo tentando di suonare decentemente da una vita. Si sta scappando a piedi, in pratica, in mezzo all’Alaska, in pieno inverno e senza una cartina in tasca.
Fortunatamente libero da responsabilità di precisione accademica posso oggi utilizzare riferimenti e fare citazioni in modo comodamente disinvolto, quindi non so più se ricordo bene né dove trovare i libri che potrebbero aiutarmi a essere più puntuale ma non riesco, in questi anni, a smettere di pensare a quale parabola si sia compiuta, nel mondo occidentale, nel giro di tre o quattro generazioni. E anche a quali paradossi siano sottesi da questo percorso. Esiste da qualche parte una ricerca che, nel tentativo di ricostruire un quadro delle condizioni di lavoro in varie epoche storiche, ha indicato che nel diciannovesimo secolo, nella famiglia contadina italiana, i maschi adulti lavoravano un quantitativo di ore medio che non ricordo, le femmine adulte uno la cui misura non ha mai smesso di sciabordarmi in testa: quattromilatrecentocinquanta. Come dire, undici ore e cinquantacinque minuti al giorno, ogni giorno dell’anno. I maschi molto meno, ovviamente – nei campi si lavora seguendo i ritmi della luce e del buio, del bello e del cattivo tempo. Insomma, tutta ‘sta manfrina per dire che il lusso di un hobby i nostri avi (ave soprattutto) non se lo potevano permettere – c’era il vino e c’era il tirare tardi a giocare a carte, sempre per i maschi. Poi vabbe’, alcuni (pochi) erano borghesi o aristocratici e allora lì la formazione artistica era parte integrante, ancorché forzosa, del curriculum legato allo status. Un’eredità di tutto questo la ritroviamo oggi nel fenomeno (esiste ancora?) dei bambini coartati nello studio del pianoforte o del violino come fattori di distinzione sociale. Roba che altro che corvée. Probabilmente un fattore adiuvante nel desensibilizzare le funzioni cognitive rispetto alla questione se sia più nobile patire le frecce e i dardi della tecnica e dei suoi requisiti o far finta di aver compreso e pestare un po’ alla cacchio sui tasti scimmiottando il maestro, cercando di capire che cosa si deve fare. Ah, dimenticavo: quando le ore del lavoro sono diminuite sono aumentate le possibilità di fare altro, non è ozioso ricordarlo.

No, perché se il mondo del lavoro, e non solo quello, oggi sta seguendo una traiettoria balistica verso l’impatto al suolo [ore di lavoro che aumentano fuori controllo, retribuzioni da gig economy, posti di lavoro che si disintegrano e altri che non sono biodegradabili neanche per sbaglio] forse forse le ragioni non sono così distanti da questo ragionamento domenicale (scrivo nel weekend, sai com’è) un po’ sciatto. Se la dis-umanizzazione è un cambiamento svalutativo ma maggioritario allora, in qualche misura, la disgregazione degli equilibri del boom postbellico (e con «equilibri» intendo anche i nuovi sbilanciamenti deteriori dell’era dell’«uguaglianza», come i baby pensionati, il prosperare dell’economia sommersa, lo sprezzo reiterato dell’ambiente naturale, e via dicendo) che si è andata via via perfezionando dai primi anni ottanta in poi, a colpi di deregulation, feticismi della mano invisibile, liberismi non meglio identificati, cattura tribale del consenso, in una sorta di fracking del piccolo mondo antico della scala sociale e dei modelli borghesi – questa disgregazione (riprendiamo fiato in un periodo decisamente troppo lungo) comincia a suonare come un disegno deliberato, un progetto, radicato, appunto, nella dimostrazione, fornita dal secolo breve, che le persone non si convincono con argomenti pertinenti e richiami all’utilizzo del libero arbitrio ma, semplicemente, dando loro a intendere cosa vogliono (leggi devono) fare, quasi sempre contro il pericolo rappresentato da qualcuno o qualcosa. Si sono così ottenute vere meraviglie – da gente che ha ricoperto con entusiasmo il ruolo di torturatore dei propri concittadini a quelli che votano stabilmente esattamente contro il proprio interesse e non serve neppure investire un dollaro per portarceli. Dittature, democrazie, il marketing abbraccia tutti, ben volentieri.

Il bassista da salotto è notoriamente un obiettivo di mercato – se gli strumenti si vendessero solo ai professionisti saremmo ancora agli equivalenti moderni degli Stradivari e dei Guarneri del Gesù – e in questo senso il mercato è sovraordinato all’ordine politico, proprio perché si radica nella legge del desiderio. Ci sono ormai troppi prodotti, troppe varianti, troppe soluzioni e configurazioni da poter confrontare veramente: molti artisti infatti si attestano, per converso, su un solo modello di strumento e un tipo di amplificazione – alcuni, come Joe Dart, non usano neppure effetti a pedale o a rack. Ma se anche poi uno avesse una catena infinita di effetti e gingilli vari non è certo un crimine, il punto è che quello che mette in campo deve servire a qualcosa, avere uno scopo che sia qualcosa di più del semplice fatto di avere messo insieme una collezione di oggetti ben recensiti. Che poi quella roba richiede tempo per essere programmata, regolata, configurata, cablata – quel che c’è va saputo usare e più ne metti e più ne devi sapere. Certo, a quel punto dipende non solo dai soldi che puoi avere ma anche e soprattutto dall’altra risorsa, quella veramente scarsa, il tempo. Ecco, oggi, nel quadro della dissoluzione del blocco del benessere di questi ultimi tre-quattro decenni, gli ultimi rimasugli delle lotte di classe sono stati spazzati via con una risata sardonica dalla marea montante delle disparità, sempre più molteplici e articolate. Senza mettersi a fare del qualunquismo spicciolo, però tutti conosciamo più o meno direttamente persone che o non lavorano perché non ne hanno bisogno o perché guadagnano bene anche facendo finta, in ruoli e incarichi spesso di profilo pubblico (ma non solo). Incrociando queste dinamiche con quelle dell’accumulo patrimoniale post secondo dopoguerra si hanno gli ingredienti che servono per trasformare il regime atavico della società piramidale in una lotteria abbastanza truccata. Il lavoro ne esce deprezzato come valore, non c’è competizione. Non deve essere un caso se anche lo studio della musica ha perso credito. E sì che le persone capaci, in grado di elargire didattica moderna, attuale, accessibile, godibile, non mancano. Ma è più forte il desiderio di potersi assemblare una bravura, comprandola a pezzi e poi vantandone il possesso e la riconoscibilità.
Nessuna bestia è così feroce da aver inventato due cose, tirandole su dritte dal mondo delle pulsioni per impastarle insieme: il mercato e la politica. Di certo non siamo bestie, no.
Solo che non andrei in giro a vantarmene.
È un percorritore di sentieri interrotti, un professionista dell’amatorialità spinta, un fan della bassa visibilità. Ha studiato amenità umanistiche ma anche il bric-à-brac aziendale. Con il secondo riesce a pagarci i conti. Lettore compulsivo di TS Eliot, Céline, Pynchon, Heller, Vonnegut, PK Dick. Ciclista da strada incidentato, ormai dismesso, curriculum da improbabile sopravvissuto. Quando formarono la band era rimasto solo il basso e quello prese. Nei decenni si è rivelata una non-scelta piena di senso.