(Le illustrazioni sono di Lucia Lamacchia, che è responsabile di quanto segue almeno quanto lo sono Ugo e Michel.)
Che poi, diciamocelo, al cinema sembra tutto più serio.
Ci sono ‘sti due tipi vestiti come le iene ma più simpatici. Indossano completo, scarpe, cravatta e cappello di feltro neri, camicia bianca e occhiali da sole. Sono in missione per conto di Dio e fuggono inafferrabili nel più grande inseguimento della storia. L’auto su cui scorrazzano per tutto il film, una Dodge Monaco berlina nera del 1974, è indistruttibile; quelle degli inseguitori, no. Scappano da polizia, marines, nazisti dell’Illinois, fidanzate, creditori, morte e tasse. Nulla è inevitabile.
Noi siamo in quattro, stipati in una Fiat 500 rossa che avanza a fatica. Ci vogliamo stare il meno possibile perché ci costa una ventina di euro l’ora. E se ci vogliono rintracciare, probabilmente gli basta cercare la nostra posizione sulla App del car sharing. Io ho la giacca strappata, Michela un livido sulla guancia che ha la forma di un piccione e Christine è vestita come una che dorme in strada. E ha anche lo stesso odore. E siamo stipati in un’automobilina minuscola. Ho provato ad aprire il finestrino ma, con quel suo accento francese, mi ha chiesto gentilmente di chiudere. Dice che ha molto freddo. Solo Michel è impeccabile, con il suo completo blu e la sua guida sicura nel traffico serale milanese.
Continuo a guardarmi intorno, sicuro che, se faccio abbastanza attenzione, riuscirò a scorgere i nostri inseguitori. Che di certo ci sono e sono numerosi. Mi concentro per vedere se, con la mia vista allenata da così tanto cinema americano, riesco a vedere il riflesso del mirino del cecchino che ci deve uccidere, i tipi che controllano i nostri spostamenti fingendo di leggere il giornale, o almeno i lampeggianti di un’auto della polizia. La cosa più insidiosa che intercetto – e sempre troppo tardi – è il ragazzo che fa roteare i birilli al semaforo o la donna rom che vuole lavare l’auto. Ho una moneta per tutti, che mica voglio sembrare un nazista dell’Illinois. Che poi… i miei nazisti mica si lanciano nel vuoto confessandosi la frustrazione di un amore sempiterno e segreto: mi è toccato di abbatterli a sediate. Che pare una stronzata, ma ci ho il braccio che mi fa malissimo. Provaci tu a sollevare una sedia da ufficio con le rotelle. Sono pesantissime. Sembro una mammoletta, ma invece, nei momenti di crisi, tiro fuori un’energia incredibile.
A proposito di energia. Conosco Michela da vent’anni. È una delle mie amiche più care. Certo. È una donna simpatica e intelligente, ma quanto è incasinata e insicura. Vive con quello stronzo schifoso di Paolo, un ubriacone manesco. Benché non lo abbia mai voluto confessare, so che la picchia. Io le dico che lo deve lasciare, che è un bastardo e che deve farsi aiutare. Lei risponde che non la picchia, che non posso capire e che è un uomo tanto sensibile.
Ecco. La sensibilità è proprio la caratteristica che avrei qualche difficoltà ad attribuire a una persona alla quale voglio bene. Di solito, se di qualcuno si dice che è sensibile, si sta cercando di sviare l’attenzione da qualcos’altro. Probabilmente è un potenziale assassino seriale o uno stragista. Se mi indicano un uomo sensibile, corro a nascondermi. Sono certo che il cecchino appostato tra i palazzi, che non riesco proprio a vedere, ha a casa qualcuno che lo definisce sensibile. Fatto sta che Michela da vent’anni vive all’ombra di uomini sensibili, mostrandosi sempre remissiva. Cerca di non farmeli incontrare, perché quando queste merde rimarcano il fatto che Michela è loro e di me si fidano perché sono quello che sono, scarico uno sciame di vaffanculo così fitto che gliene rimarranno sulla faccia e sulla camicia per settimane.
Da qualche giorno è emerso un suo aspetto bestiale che proprio non le conoscevo.
Mica una di quelle cose che ti fanno scoprire che una persona che stimi, sempre molto elegante, fa delle robe gravissime e imperdonabili, tipo non cambiarsi le mutande tutti i giorni o piegarsi sul piatto per mangiare la minestra. Proprio scatti animaleschi che la muovono con agilità e forza insospettabili. Michela è fortunata: ha un bel corpo, uno di quelli progettati per durare nel tempo, ma è una dote naturale. Mica le ho mai sentito parlare di ore passate in palestra a sudare e sbuffare. Mi racconta delle lunghissime sessioni per le unghie, la pulizia del viso, la piega e il colore. Non le ho mai sentito dire niente di tapis roulant, pesi e cyclette. Le voglio un sacco di bene anche per questo. Che ci avremmo da dirci sugli esercizi per sviluppare il deltoide? Ne so molto di più su bagni di colore, ombretto e tacchi a stiletto.
Eppure, negli ultimi giorni, ho vista Michela saltare alla gola di individui molto più grossi di lei. Balzi da animale selvaggio, con annessi ringhi e ululati. Ha cercato di uccidere perfino me. E sono il suo migliore amico. E avevo ragione, eh. Non glielo perdonerò. Ha messo il curry nel ragù. Tanto valeva che non si cambiasse le mutande tutti i giorni. O che fosse sensibile.
Non era male quel ragù, però…
Quando me la sono trovata nel letto sporca di sangue e fango ho pensato che fosse affetta da licantropia. Ho pensato proprio a quella condizione psichiatrica e patologica alla quale non avevo mai creduto. Mi pareva che fosse la trasposizione clinica di uno dei personaggi tipici del cinema dell’orrore: un maschio bianco che, una volta al mese, quando vede la luna piena, si copre di peli e inizia a correre nei boschi alla ricerca di prede. Lui si mangia qualche pecora e qualche vergine e poi diventa preda a sua volta, inseguito da una folla inferocita che agita nell’aria torce e forconi. Di solito il film finisce con un incendio, una pallottola d’argento e un lupo che perde il pelo e il vizio e torna a essere il noioso umano di sempre. E se ci pensi, quest’ultima trasformazione da lupo a uomo è la metafora assoluta della nostra vita. Quando finalmente arriviamo a godere del momento assoluto, quello per cui è valsa la pena vivere, qualcuno ci ammazza, anche solo in senso figurato, e morendo torniamo la solita pappetta di noia e sbuffi.
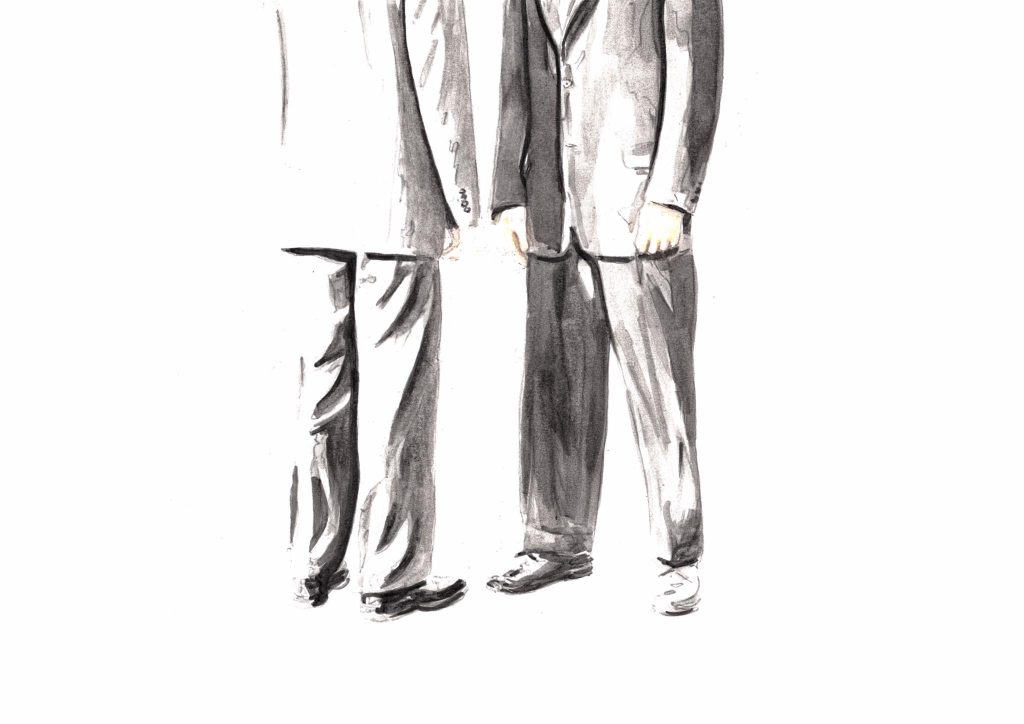
«Noi siamo scesi.», dice Michel, appoggiando la mano sulla spalla di Ugo, «Cosa fai? Resti lì così ti porta via il prossimo che prende la city car?»
Ugo si guarda attorno un po’ stupito.
«Il vostro amico è folle.», bisbiglia Christine, «Prima voleva aprire la finestra con questo freddo. Quando gli ho detto di non farlo, si è messo a parlare da solo, dentro la testa, muovendosi di qua e di là. Folle. Folle.»
Scendono dall’auto. Hanno parcheggiato accanto a un edificio grigio. I muri sono tempestati di scritte. Una stratificazione di vernici che inspessisce le pareti. A leggerle con attenzione si potrebbe arricchire il pensiero sociologico contemporaneo. Un complesso industriale dismesso, che si sviluppa attorno a catene di montaggio lungo le quali, da un quarto di secolo, non si muove più nessuno. Nel momento di massima fulgore, in quell’area si alienavano 19.000 individui, capaci di produrre ottocento vetture al giorno.
Umani meccanizzati che costruivano macchine, con lo sguardo fisso sulle proprie mani intente a ripetere sempre gli stessi movimenti.
Dopo la dismissione dell’impianto, lo stabilimento è sparito agli occhi di tutti. Quel gigantesco edificio è diventato ambiente. Gli si passa accanto, chiusi in automobili prodotte altrove, diretti verso altri posti di lavoro. L’accurata distribuzione di rotatorie evita code e rallentamenti eccessivi. Non si perde tempo con l’archeologia industriale.
«È proprio qui.», dice Christine, «Entriamo!»
Entriamo.



