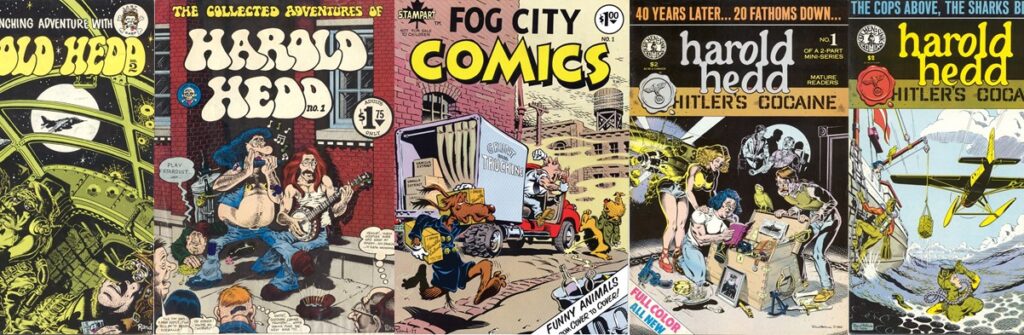Devo essere rimasto segnato da bambino da quei solidi di plastica o legno colorati. L’inesprimibile piacere che mi dava il metterli insieme sul pavimento della scuola materna per formare un disegno, o l’incolonnarli in modi arditi fino all’inevitabile crollo, mi dev’essere rimasto addosso, come un tatuaggio. Mi dev’essere rimasto negli occhi.
Anche l’esperienza tattile faceva la sua parte, certo, ma imputo a quelle forme impresse nella retina la mia passione per le pagine a fumetti.
Quelle che amo di più, infatti, quelle che mi colpiscono definitivamente lo sguardo prima ancora di aver visto le parole o letto le immagini, sono quelle la cui composizione delle vignette è decisa da una struttura sotterranea. Quelle che sembrano un’accozzaglia di regoli appoggiati sulla pagina con sapiente e ossessiva intelligenza. Con intuito geometrico.
Non sopporto quei fumetti dove le vignette sono buttate a caso, messe lì giusto perché si deve. Visto che quando apro un qualsiasi albo la prima cosa che mi entra negli occhi è il mosaico che le vignette compongono -quello che alcuni chiamano arte sequenziale, illudendosi che tale scansione frammenti semplicemente lo scorrere del tempo- pretendo da lettore una devozione quantomeno maniacale dietro il loro schema. Il fumetto, prima di tutto, è la pagina che ti si para davanti quando lo guardi.

Prendi i giapponesi, loro raramente deludono. Ce l’hanno nel sangue. Guarda il maestro Hirohiko Araki, il maestro Jiro Taniguchi e pure quell’altro genio, il maestro Katsuhiro Ōtomo. Ecco, proprio quest’ultimo, quando fa Domu (in Italia col sottotitolo Sogni di bambini) e mette dentro le vignette dei palazzi giganteschi che altro non sono che pagine nella pagina, strabordanti finestre, vale a dire vignette dentro vignette, mi seduce alla prima occhiata. La grammatica delle sue forme mi si è già impressa addosso. Anche in Akira, con tutti quegli edifici distrutti e devastati, l’impressione è che distrutta e devastata sia la pagina, prima ancora delle immagini che contiene. La pagina è già una vignetta, un palazzo perfetto, pronto a frantumarsi e a crollare al suo interno in miliardi di piccoli regoli narrativi. Frammenti di tempo da riunificare (a scelta, quindi magari anche no).
Oppure i francesi, con quelle loro impalcature tutte tese alla verticalità. Penso soprattutto a Hergé e alla sua genia, fino a Vittorio Giardino e oltre. Lì, la geometria penetra dentro al disegno.
A ben guardare, l’insopportabile Tin Tin (proprio il personaggio) un insieme di solidi in movimento. E poi quei colori piatti, tutto è netto, chiaro come la linea che lo ha definito, senza sfumature. Un ingranaggio che continua a esercitare un fascino insondabile. La solidità geometrica si spinge fino agli snodi della trama e alla ripetitività speculare con cui si esprimono i protagonisti (come un bambino che vuole sempre la stessa fiaba prima di addormentarsi, le gag del professor Girasole mi fanno ridere ogni volta, con puntuale ossessività).
La famosa “gabbia italiana” invece, quella tipica degli albi Bonelli o di “Topolino”, viene spesso offuscata dall’uso che ne viene fatto. Ha una conformazione perfetta per esploderti negli occhi, ma il più delle volte viene invece depotenziata dalle figurine parlanti al suo interno. Spesso mi è capitato di trovarla in contesti inaspettati e di vederla davvero risplendere, in tutta la sua forza strutturale. Penso ad esempio a una cosa piccola e potentissima come Una sorella di Bastien Vivés o addirittura all’Immortal Hulk di Al Ewing e Joe Bennet, dove le sei vignette quadrate, completamente impreviste in mezzo a quelle pagine americane senza capo né coda, tutte muscoli, fulmicotone e linee diagonali, quando appaiono all’improvviso sembrano un’idea innovativa, un rompere la gabbia per estremismo opposto.

Ma la vera emozione, il piacere quasi fisico, la droga che mi fa sentire come il Topolino tossico di Andrea Pazienza che ansima «Vignette! Vignette! Vignette!» con il laccio emostatico fra i denti, arriva con le pagine scritte da Alan Moore e con il Berlin di Jason Lutes.
Berlin è una struttura così precisa e complessa che al di là della lettura per immagini ne contiene certamente un’altra per composizione delle vignette. Potrebbe essere sfogliato omettendo tutti i disegni e i testi, e godendo solo dei mosaici di regoli vuoti con cui Lutes ha costruito la vera essenza della sua narrazione.
I fumetti di Moore invece, a qualsiasi disegnatore siano affidati, sono il perfetto punto di arrivo di questa ossessività formale. Riguardo alla sua scrittura delle pagine si può tranquillamente parlare di pattern: schemi ripetuti, mescolati, abusati (dalle nove vignette di Watchmen e From Hell, fino alle quattro strisce orizzontali e tre colonne verticali di Providence, a tutte le variazioni sul tema che stanno nel mezzo). Se letti in sequenza, con senso cronologico lineare, funzionano come un metronomo incessante, spietato. Se esperiti in senso non lineare ecco invece l’effetto ipnotico, mantrico, ad agire su chissà quali centri sottili della percezione, provocando quel piacere che sta precisamente a metà fra il sentimento e la ragione. Fra l’anima e il corpo.
Una cosa simile può succedere anche con l’incredibile Stray bullets di David Lapham, autore americano che racconta cose americane con un tratto all’italiana e un’impalcatura di vignette alla francese. Una summa di forme solide usata con fermezza infrangibile, che arrivano a sciogliersi, non viste dal lettore, facendo emergere alla fine, cruda, solo la storia.
Ovunque nei fumetti, sottotraccia – e per chi lo vede, in primo piano – c’è il complesso intrico geometrico dei regoli, il volto sotterraneo della pagina.
Sì, un gioco di bambini.
Scrive fumetti e scrive di fumetti, poi scrive anche canzoni e le canta, insieme a quelle degli altri che gli piacciono. Il suo sito è www.francescopelosi.it.