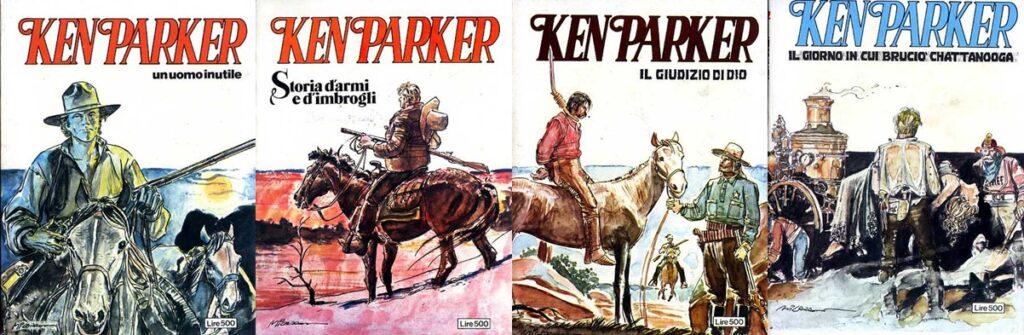Quando il vento del Maggio travolge la Francia, Gilles Deleuze è al culmine della sua carriera accademica. Regge due cattedre all’Università di Lione: Morale et sociologie e Philosophie générale. Ha pubblicato almeno una dozzina di titoli, tra i quali alcuni testi fondamentali come la monografia su Spinoza e Differenza e ripetizione, e sta lavorando a quello che sarà il suo primo vero capolavoro: Logica del senso (che uscirà nel 1969). Proprio in questo mese ha dato inizio al suo impegno sociale e politico, schierandosi – in totale solitudine all’interno del corpo docente – con le ragioni degli studenti in rivolta. Se questa netta presa di posizione gli costerà un certo isolamento nel mondo accademico, lo trasformerà però in un intellettuale pubblico, il cui pensiero avrà un peso rilevante nel decennio successivo.
Il suo amico Michel Foucault dirà, proprio a proposito di Logica del senso, che «une fulguration s’est produite, qui portera le nom de Deleuze… un jour, peut-étre, le siècle sera deleuzien».
Agli inizi del 1969, però, tutto sembra crollare. La tubercolosi, che lo mina da sempre, si complica al punto che deve sottoporsi a un complesso intervento di toracoplastica. L’operazione è talmente invasiva (praticamente gli viene fatto atrofizzare un polmone) che la convalescenza durerà quasi un anno. Deleuze la trascorre con la moglie un po’ nel Limousin, un po’ – durante l’estate – nella valle della Loira, a Dhuizon, dove ha affittato un castello.
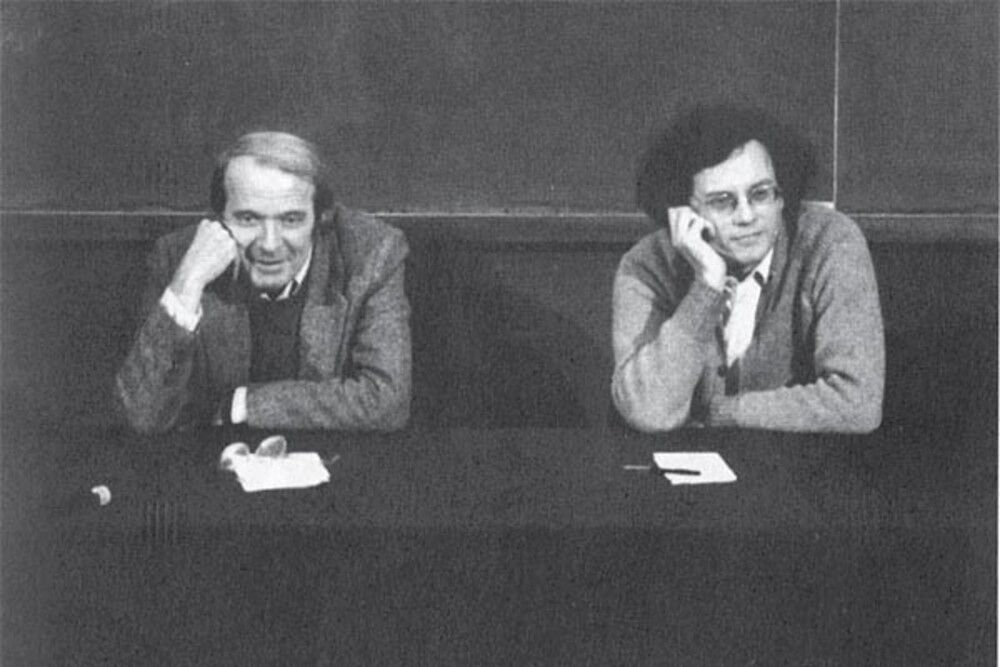
La noia di questa lunghissima convalescenza, che aggrava l’alcolismo da cui già era in parte dipendente, trova sollievo, proprio qui a Dhuizon, nella conoscenza di Felix Guattari, introdottogli dal comune amico Pierre Muyard, che diverrà quasi senza soluzione di continuità, amicizia e assidua frequentazione.
Convintamente antiautoritario, al punto da essere espulso dal Partito Comunista Francese per le sue critiche all’assetto gerarchico di stampo sovietico, Guattari era un brillantissimo studente di medicina che rivolse molto presto la sua attenzione alla psicoanalisi. Nonostante, proprio per quell’antiautoritarismo che gli faceva rifiutare titoli e diplomi, non si fosse specializzato (lo farà in seguito, alla scuola di Jacques Lacan), Jean Oury lo volle nel gruppo con cui fondò la famosa e avanzatissima clinica psichiatrica di La Borde a Cour-Cheverny, piccolo centro della Valle della Loira. Guattari aveva 23 anni e resterà a lavorare in questa clinica per tutta la vita, sviluppando una delle più originali e rivoluzionarie interpretazioni dell’inconscio. Il fatto che quell’estate del ’69 i suoi due comuni amici si trovassero a una distanza di 20 km, induce Pierre Muyard, che era il medico più in vista di Cour-Cheverny, a farli incontrare. Certo che l’esperienza di Guattari avrebbe potuto giovare alla depressione di Deleuze, un giorno di luglio Muyard carica in macchina il primo e lo porta al castello dove alloggiava il secondo. Sappiamo come si chiuderà la vita di Deleuze e quindi dubitiamo che sia mai uscito dalla depressione causata dal suo grave stato di salute, ma se c’è una cosa cui possiamo essere certi è che l’amicizia indissolubile che nacque quel giorno ha segnato un punto di svolta nella storia del pensiero, del nostro desiderio e del nostro immaginario. Nel 1972 infatti, dopo una lunghissima gestazione, esce per i tipi di Minuit, L’Anti-Œdipe, opera profondamente seminale scritta a quattro mani dai due amici.
Quello che vi sostengono è che la realtà è costruita dal nostro desiderio, che ci spinge e trascina verso un oggetto che non c’è ma che noi creiamo con quel protenderci. Questo desiderio non giunge mai alla soddisfazione di un bisogno, se accadesse ciò significherebbe la fine del capitalismo e della società occidentale, ma si perpetua nelle strutture narrative che ogni volta mettiamo in atto.
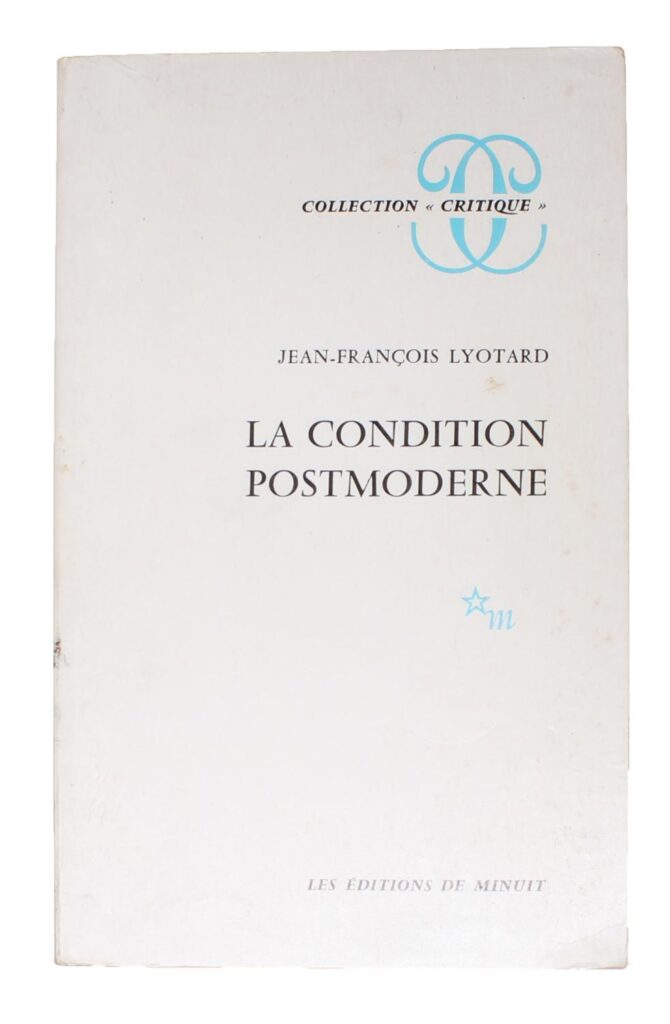
Nel 1974, influenzato dalla lettura dell’Anti-Œdipe, Jean-François Lyotard pubblica la prima delle sue due opere fondamentali: Economia libidinale. Partendo dal discorso di Deleuze e Guattari, per cui il desiderio non poteva più essere considerato una pulsione trascendentale soddisfacibile solo con strumenti escatologici, ma un meccanismo immanente gestibile solo con strumenti umani, Lyotard sostiene una cosa apparentemente trascurabile, ma che quando l’approfondirà nella sua opera successiva, cambierà tutti i nostri paradigmi interpretativi. La dimensione libidinale, dice, non è solo l’istanza produttrice di tutte le storie che ci riguardano come singoli, ma lo è anche di tutte le grandi narrazioni (religiose e ideologiche) che hanno cercato e cercano di interpretare il mondo. Cinque anni più tardi, con La condizione postmoderna Lyotard aggiusta il tiro: la modernità, il periodo precedente a questo nuovo tempo che stiamo vivendo, era stata caratterizzata, in senso filosofico e politico, da sintesi interpretative che lui definisce grands récits, meta-racconti collettivi (cristianesimo, illuminismo, idealismo, marxismo, liberalismo) che fornivano, attraverso il continuo rimando a un futuro positivo, la legittimazione a pensare la storia dell’umanità come un cammino progressivo ed emancipativo. Semplificando, forse anche in modo eccesivo, il pensiero di Lyotard, quello che sostiene è che, a seguito delle modificazioni avvenute nella società post-industriale, questi grandi sistemi palingenetici sono andati lentamente esaurendosi, lasciando il posto a una diffusa incredulità nelle meta-narrazioni. Le nuove generazioni non credono più al futuro, sanno che non esiste, e vivono in un luogo deterritorializzato in cui tutto il tempo confluisce.
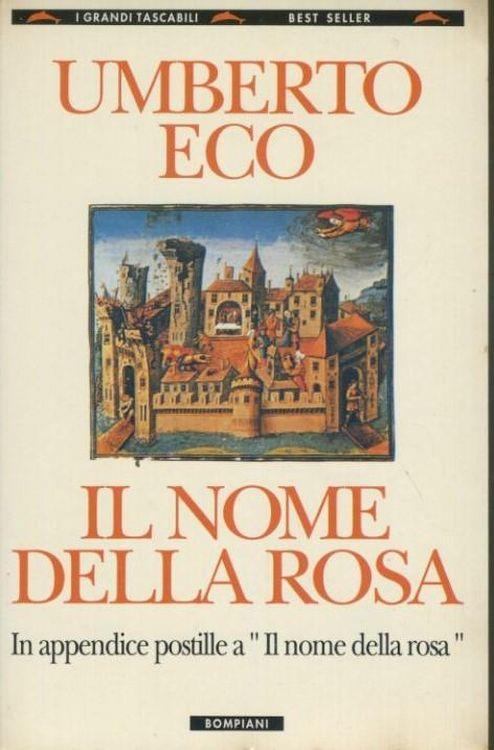
Il primo romanzo postmoderno italiano è, senza alcun dubbio, Il nome della rosa, al quale Umberto Eco (che conosce l’opera di Lyotard sull’originale e non sulla farraginosa e a tratti incomprensibile traduzione italiana) fa seguire, nel 1983 sulle pagine di “Alfabeta”, delle Postille in cui spiega la genesi del romanzo. In questo saggio c’è un paragrafo intitolato, “Il postmoderno, l’ironia, il piacevole” in cui Eco dà una precisa spiegazione di come si concretizza il postmoderno lyotardiano in un preciso universo narrativo.
Quelle poche righe, probabilmente non lette e recepite – come capita spesso con i testi teorici – solo per sentito dire, hanno convinto almeno due generazioni che il postmoderno significhi ficcare dentro alle proprie opere quante più citazioni e riferimenti possibili. Non è così. Quello che dice Eco è che, secondo il paradigma di Lyotard, il principale cambiamento narrativo rispetto alla specificità classica e a quella moderna (e non è un caso che il romanzo di Eco sia ambientato proprio in quel tempo di mezzo, il medioevo, in cui avviene il passaggio da una all’altra) è che, nel postmoderno, testo, autore e fruitore sono posizionati sullo stesso piano. Sono “posizionalità discorsive”, e nessuna di esse può avanzare pretese di dominio sulle altre. Nella classicità il narratore e il fruitore erano istanze esterne al racconto e al centro di tutto stavano i fatti narrati, mentre nella modernità è il narratore a prendere il dominio e a controllare con la sua onniscienza il narrato. Nel postmoderno nessuna istanza è esterna alla narrazione, se il narratore e il fruitore non possiedono lo stesso sapere non può darsi narrazione. Il postmoderno può essere definito come un «sappiamo tutti la stessa cosa, di conseguenza siamo tutti la stessa cosa nello stesso momento». Nello stesso anno del romanzo di Eco, il 1980, esce Millepiani, volume in cui Deleuze e Guattari portano a conclusione il loro pensiero. Se l’Anti-Edipo si muoveva in direzione antikantiana e antifreudiana, sostenendo e dimostrando che l’inconscio non è un teatro dove avvengono le rappresentazioni, ma una fabbrica in cui le rappresentazioni vengono prodotte, in questa nuova opera si muovono in direzione postkantiana, dando un’impostazione “costruttivista” alla teoria della molteplicità dei saperi nella produzione di senso. Non esiste una radice da cui la narrazione si sviluppa in senso verticale e univoco. La narrazione è una struttura orizzontale, fatta di connessioni e di eterogeneità, in virtù delle quali ogni punto è connesso a qualsiasi altro, senza ordine gerarchico. La forma di questa struttura non è un dato fisso e immutabile, con un ordine preciso di significazione, quanto piuttosto un elemento dinamico, che fa della dialogicità con l’altro (il fruitore) la sua più profonda natura ontologica.
Per dare un nome a questo concetto, Deleuze e Guattari, ricorrono a una metafora botanica, quella modificazione del fusto delle piante erbacee, sotterraneo come le radici ma con decorso, a loro differenza, orizzontale, che viene detto rizoma.
«Il rizoma collega un punto qualsiasi con un altro punto qualsiasi, e ciascuno dei suoi tratti non rimanda necessariamente a tratti dello stesso genere, mettendo in gioco regimi di segni molto differenti e anche stati di non-segni. […] Rispetto ai sistemi centrici (anche policentrici), a comunicazione gerarchica e collegamenti prestabiliti, il rizoma è un sistema acentrico, non gerarchico e non significante.»
Secondo la definizione che ce ne hanno data i due autori, ogni struttura narrativa non è più un dato discorsivo (o visivo se ci riferiamo al mondo delle immagini), ma un diagramma operativo che richiede da tutte le istanze messe in gioco (autore, testo, fruitore) le stesse competenze per farlo funzionare.
Due anni dopo Millepiani, e un anno prima della postilla di Eco, nelle sale cinematografiche esce Blade Runner.

(continua)
Non fa un cazzo da anni, ma è invecchiato lo stesso. Vive a Milano, e non potrebbe farlo in nessun’altra città italiana. Legge e parla di fumetti dal 1972 (anno in cui ancora non sapeva leggere). Ha una cattiva reputazione, ma non per merito suo. Ama e praticava la boxe, poi si è rotto. Beve tanto in compagnia di gente poco raccomandabile, tipo Paolo con il quale – per colpa di una di quelle bevute – si è ritrovato a curare QUASI.