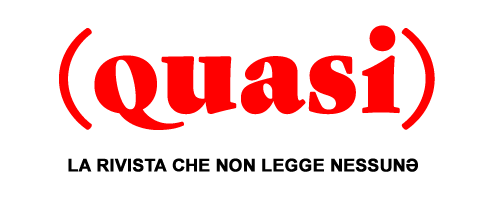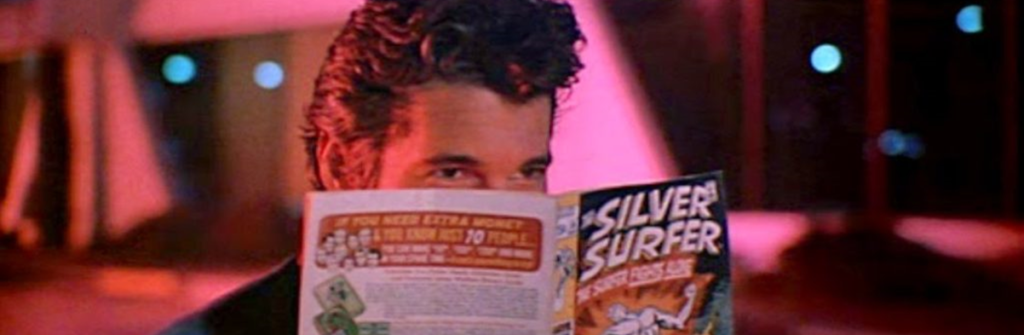Nel settembre del 1982 gli equilibri della mia vita da ragazzo di provincia sono sconvolti. Sto per compiere quattordici anni e ho esaurito il numero di anni di scuola che, in quel momento, costituiscono l’obbligo. Da quel momento, è una scelta. Abbastanza obbligata per me, ho due sorelle più grandi (una di quattro e l’altra di cinque anni) che stanno proseguendo gli studi: la prima si è già iscritta all’università, economia e commercio; l’altra conseguirà la maturità entro la fine dell’anno scolastico, non ci sono dubbi.
Poca voglia di studiare, di lavorare, di fare qualsiasi cosa. Mi interessano solo i fumetti e il karate. Non è vero. Sto riducendo l’estensione dei miei interessi. Mi piace tantissimo il corpo femminile, ma lo conosco solo ed esclusivamente attraverso i fumetti. Le ragazze che fanno karate si infagottano in abbondanti giacche bianche, strette in vita dalla cintura, che fanno scomparire le loro forme.
Nonostante la poca voglia di studiare, mi sono iscritto a un liceo scientifico a Saronno, abbastanza lontano da casa. Abito a Senago e, per quasi quattordici anni, mi sono mosso pochissimo. Saronno è l’avventura: una camminata fino alla fermata del bus, che è a un paio di chilometri da casa; poi mezz’ora in piedi, stipato in un torpedone che mi conduce fino alla stazione; infine un altro chilometro fino all’ingresso della scuola. E, all’uscita, dopo cinque o sei ore di noia poco proficua, lo stesso percorso, al contrario.
La noia non uccide. Lo so per certo: l’ho provato sulla mia pelle.
Tutto quel percorso è rallegrato da un unico evento: in stazione c’è l’edicola meglio fornita che io abbia mai visto in tutta la mia breve vita. Ha una larga sezione in cui ospita decine di pubblicazioni a fumetti. E mi sembrano tutte bellissime. Sono un liceale quattordicenne e ho pochissimi quattrini: sono costretto a scelte continue, che si risolvono nel sistematico conteggio accurato di banconote stropicciate e monetine.

In una mattina di dicembre, ne sono certo, ho duemilacinquecento lire nel portafogli. Vedo il nuovo numero di una rivista che ho già preso una volta e che mi piace poco. Si chiama “Pilot” e in copertina, in un riquadro rosso, c’è una donna bruttina, con un grosso naso e occhi a palla, che corre verso di me, impugnando una pistola automatica. Uno strillo me la presenta: «Irresistibile! Lili Fatale di Lauzier».
Dello strillo, neanche mi accorgo. Sono perso nelle gambe della ragazza: nello slancio della corsa le si è sollevata la gonna e riesco a vedere guepiere, calze e slip. Vergognandomi moltissimo, compro l’albo sperando che l’edicolante, indifferente a tutto come sempre, non mi dica niente. Poi lo nascondo nello zaino per paura che qualcuno di quelli che incontro abitualmente sull’autobus lo veda e mi classifichi come pervertito. Quanto male ha fatto la provincia all’educazione sentimentale di tanti di noi.
Arrivato a casa, mi chiudo in una stanza e godo del mio bottino. Ed è una delusione. Quello che trovo nel decimo numero di “Pilot” mi lascia freddo. Ci sono anche cose belle e importanti – come La città che non esisteva di Christin e Bilal o un fumetto breve di Regis Franc – ma in quel momento non mi dicono nulla. Arrivo, a un certo punto, al fumetto dedicato al personaggio in copertina, la seconda puntata di Lili Fatale.

Mi piacerebbe dire quando la critica sociale di Lauzier mi abbia cambiato; quanto abbia recepito e introiettato il racconto sottile e pervasivo che si infilava sotto la pelle del lettore, pungolandone il sistema di pregiudizi e mettendo alla luce la sua assoluta stronzaggine. Niente di tutto ciò. Sono altri i motivi per i quali ho guardato le pagine di quel fumetto fino a stamparmele nella memoria indelebilmente.
Ci sono due spie, Viviana “l’indossatrice”, bruna e dai lineamenti raffinati, e Lili Fatale “la solletica”, bionda e nasona. Usano le armi, combattono, seducono, vengono torturate, sparano e un sacco di altre cose irrilevanti. La sola cosa che mi interessa è che hanno corpi, fasciati da vestiti aderentissimi o, più semplicemente, nudi, che non riesco a smettere di guardare.
Sono corpi tracciati con una precisione sublime, da grafico pubblicitario abituato a usare i pennarelli per disegnare rapidamente immagini leggibili, prive di ambiguità o astrazioni. Lauzier ha una conoscenza spaventosa dell’anatomia femminile e la rappresenta depositando il minor numero possibile di segni. E quella leggerezza, che si esprime nei volteggi acrobatici di quei corpi bellissimi, mi rapisce. E mi eccita.

Ma c’è qualcosa che non torna. So con precisione qual è il big bang del mio immaginario erotico. Certo, come tutti i lettori di fumetti della mia generazione, mi sono formato leggendo di nascosto albi tascabili vietati ai minori (disegnati da Leone Frollo, Giovanni Romanini e Sandro Angiolini), e sono stato sedotto dai corpi delle supereroine inguainati nel latex (in un’occasione, Alberto Bonanni che è l’uomo invisibile di QUASI, quello cui dobbiamo tutte le bellissime testatine, mi ha detto: «La vedova nera di Gene Colan non aveva un costume; quello era body painting!»). Ma quello che mi ha davvero trasformato, con piccole ossessioni ricorrenti, è stato l’incontro fortuito con un paio di numeri di “Alterlinus”, nei quali ho scoperto Moebius (con la splendida mutaforme di The Long Tomorrow), Vaughn Bodè, Richard Corben e Georges Pichard. Corpi pieni, pesanti, carichi di segni. All’estremo opposto rispetto al nitore, alla pulizia e alla leggerezza di Lauzier.
Non mi sono pentito di aver speso quelle duemilacinquecento lire. Hanno contribuito a rendere più articolato il campo delle mie passioni erotiche che, per alcun anni ancora, si sarebbero esaurite nelle pagine dei miei amati fumetti.
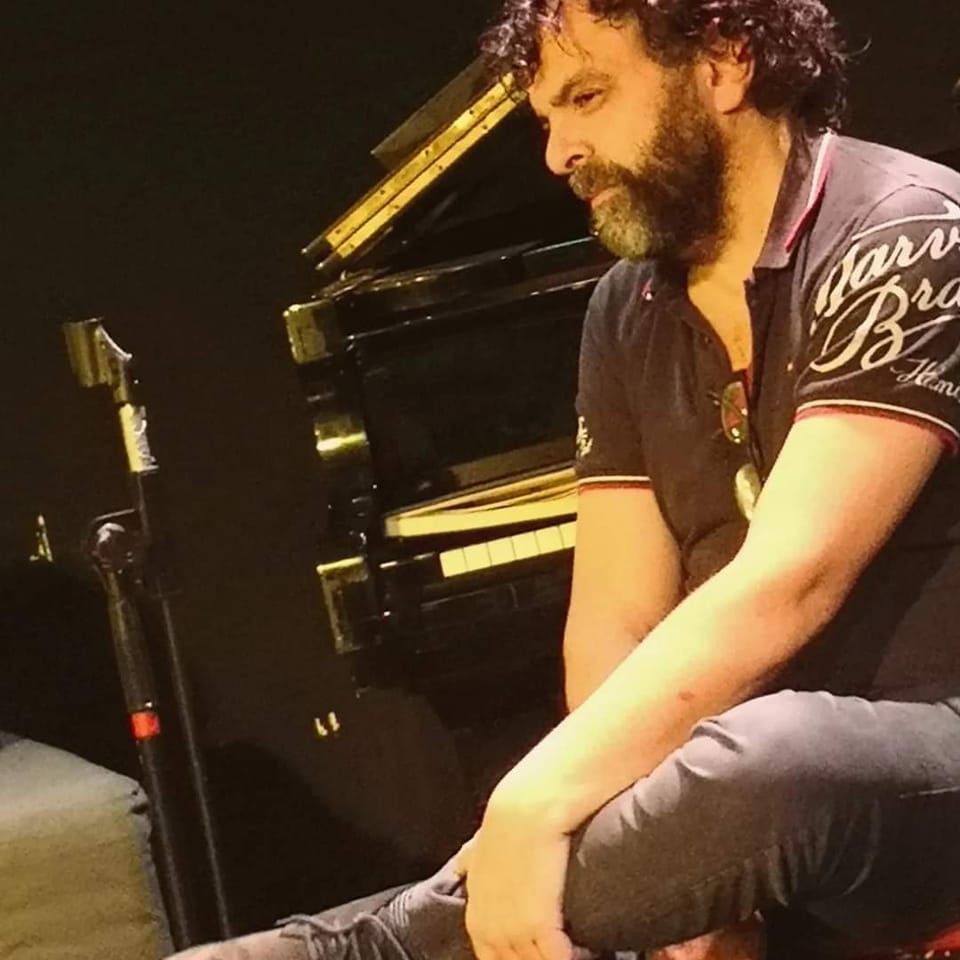
Scrive e parla, da almeno un quarto di secolo e quasi mai a sproposito, di fumetto e illustrazione . Ha imparato a districarsi nella vita, a colpi di karate, crescendo al Lazzaretto di Senago. Nonostante non viva più al Lazzaretto ha mantenuto il pessimo carattere e frequenta ancora gente poco raccomandabile, tipo Boris, con il quale, dopo una serata di quelle che non ti ricordi come sono cominciate, ha deciso di prendersi cura di QUASI.