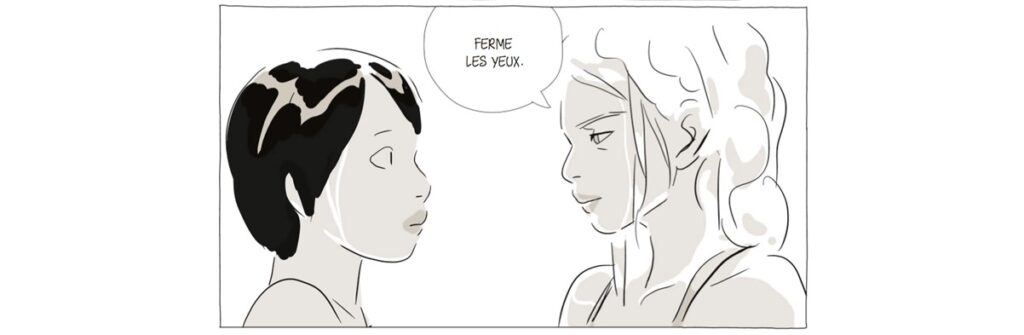Parlando di Dandadan di Tatsu Yukinobu con la commessa della mia fumetteria di fiducia, dicendole quanto fossi sconvolto dal modo in cui mi ha completamente avvinto, ragionavamo insieme sugli shonen manga degli ultimi anni. Discorsi forse un po’ oziosi, su come i vari Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers o persino L’attacco dei Giganti non ci avessero minimamente appassionato né convinto, con il loro reiterare personaggi e situazioni un po’ sempre uguali (lo so, manca all’appello One Piece, ma quello l’ho perso all’inizio e non ho più avuto il coraggio di recuperarlo; per fortuna ci sta pensando Boris).
A un certo punto lei dice: «Il mio shonen – nel senso di quello con cui sono cresciuta – é stato Naruto».
Per un attimo mi son sentito spiazzato. E il mio shonen qual è stato?
La risposta non ha tardato ad arrivare: Dragon Ball, che altro? Avevo dodici o tredici anni, l’età perfetta per leggere quel tipo di manga, e Star Comics aveva da poco iniziato la pubblicazione dell’opera di Toriyama Akira in Italia, la prima collana monografica a essere proposta con la lettura originale, da destra a sinistra.
Dragon Ball è diventato in qualche modo lo stereotipo dello shonen manga di combattimento, con i suoi eterni tornei, allenamenti infiniti e avversari sempre più forti per battere i quali é necessaria una crescita esponenziale delle capacità del protagonista e dei suoi amici.
Ma Dragon Ball nei suoi primi numeri era anche altro. Prima delle grandi battaglie per salvare la terra e dei pianeti lontani invasi da dittatori spaziali, Dragon Ball faceva soprattutto ridere, e tanto, con un umorismo il più delle volte demenziale e con continue e disinibite allusioni sessuali, buttate sulla pagina senza remore né moralismo.

La rappresentazione esplicita della sessualità, sia in modo morboso che divertito, è un tratto tipico della cultura giapponese da molti secoli (penso, su tutte, alla ukiyo-e di Hokusai con la donna a gambe aperte avvolta fra i tentacoli del polpo) e a questa si intreccia spesso la messa in scena libera di umori corporali e escrementi di vario genere (e qui andiamo dalle gare di peti rappresentate negli e-makimono del periodo Edo all’Arale di Dottor Slump che gioca con la cacca).
Jean-Marie Bouissou, che non è un critico di fumetti, ma che ha scritto un bellissimo libro intitolato Il manga. Storie e universi del fumetto giapponese, dove con piglio sociologico cerca di raccontare il contesto storico in cui il manga si è evoluto e anche le varie difficoltà dell’occidente nel capire quello stile, scrive:
«Agli occhi dei giapponesi il peto elevato al rango di arte marziale, il dottore specializzato in escrementi o le giovincelle in microgonna che frequentano il liceo di quartiere non sono né delle mostruosità né delle assurdità. Provengono dallo strato più profondo della cultura popolare, trasmesso lungo i secoli in diverse forme di narrazione grafica e dai quali sono trasmigrati, quale fattore ereditario, nel manga contemporaneo».
Dandadan recupera pienamente queste istanze dalla tradizione e le ripropone usando però tutta la cinica disinvoltura del nostro tempo.
Nel manga in questione vediamo una razza aliena che vuole prelevare gli organi genitali dagli umani (e che siano maschili o femminili, li chiama comunque “banana”), una nonna-demone (la straordinaria “Turbononna”) che fa sparire pene e testicoli al maschio che maledice, ragazzine del liceo che per un motivo o per l’altro rimangono sempre in mutande e reggiseno e una maga vecchia di secoli che ha però un corpo giovane e procace, il tutto commentato dal linguaggio sboccatissimo dei protagonisti. Nel terzo tankobon, uscito da poco in Italia per J-Pop, comincia addirittura una sorta di ricerca delle “sette sfere del drago” con la differenza che le palle da trovare sono solo due e sono quelle del protagonista.
Quella che sembra un’ossessione erotica di Tatsu, il suo mettere gli organi genitali dei suoi personaggi al centro del l’intreccio come fossimo in una qualsiasi barzelletta da bar, scardina in realtà il senso di disagio che comunemente proviamo (tanto in occidente quanto in oriente) di fronte a questi argomenti. Dandadan sembra un enorme gioco di bambini, una scoperta continua, come quando in tenera età si inciampa, per istinto o coincidenza, nella dimensione sessuale senza filtri né imbarazzi razionali e in maniera totalizzante, eccessiva, per poi dimenticarsene un attimo dopo. Non c’è ancora l’ossessività degli adulti, il senso di desiderio e possesso, c’è solo il gioco, la risata spontanea e sopra le righe dei bimbi al semplice suono della parola “cacca”.

Altro aspetto che Tatsu riprende dalla tradizione é l’elemento paranormale della possessione demoniaca. Un’antica leggenda giapponese dice che gli oggetti, dopo un secolo dalla fabbricazione, si trasformano in yôkai, come se un demone risiedesse in loro e dopo cento anni si palesasse per animarli, mutandoli in mostri. Questa piccola e suggestiva storia è alla base di molte narrazioni giapponesi che parlano di robot (gli oggetti) che si trasformano o che hanno un’anima (il proprio yôkai) a partire da Astro Boy di Tezuka Osamu per arrivare al Ghost in the shell di Masamune Shirow e anche a Isayama Hajime è al suo Attack on Titans.
Guardando il giovane Ken Takakura di Dandadan che può trasformarsi in un mezzo demone “liberando” la maledizione che la Turbononna gli ha lanciato, poi, non si può fare a meno di pensare a Le bizzarre avventure di Jojo e all’invenzione più fortuna di Araki Hiroiko: lo stand.
«Ne Le bizzarre avventure di Jojo», dice lo stesso Araki, «l’energia psichica e spirituale emessa dagli esseri viventi viene chiamata “stand”. In questa storia, l’energia spirituale viene rappresentata visivamente apparendo alle spalle dell’essere umano o dell’animale che la genera come se fosse un essere reale».
Proprio come uno yôkai che infesta un oggetto trasformandolo in un mostro, così gli stand di Jojo e le “maledizioni” di Dandadan trasformano radicalmente i personaggi, donano loro un “potere”, grazie alla forza spirituale che sprigionano nelle più svariate forme. Un’idea che richiama direttamente le filosofie animiste e che chissà come svilupperà in futuro Tatsu.
Certo è che il suo manga, sotto all’apparenza – per noi occidentali – triviale e greve, riporta un complesso intreccio di riferimenti culturali e emotivi che rendono inaspettatamente ricca la lettura, sostenuti da un segno incredibile, netto, plastico e potente, e da una capacità da maestro di decidere quando il lettore deve ridere e quando deve preoccuparsi o emozionarsi. La narrazione di Tatsu, se si fa tanto a posarvisi gli occhi e a entrarvi in contatto, ti incatena con la sua velocità e intelligenza, non lasciando respiro fra colpi di scena, battute e situazioni imprevedibili e ricordando per certi versi – con le dovute distanze – la lezione dinamica della pagina di un maestro come Kojima Goseki.

Tastu è stato l’assistente di Fujimoto Tatsuki (quello di Chainsaw Man), si è fatto le ossa alla svelta ed è già decollato con la sua serie personale. Forse, l’unica cosa in cui difetta la sua opera, è la poca profondità psicologica e sentimentale, ma essendo Dandadan prevalentemente uno shonen di combattimento (con alcune derive seinen), non c’è da preoccuparsene poi troppo.
Per quanto mi riguarda, non riesco già più a staccarmene. Una volta finito il primo volume, mi sono ritrovato pienamente invaso dal sentimento di attesa per “il prossimo numero” che provavo ai tempi di Dragon Ball. Chissà, forse ho trovato un altro mio shonen.
Di certo, per Dandadan, resta valida la bellissima definizione di Aline Kominsky-Crumb del fumetto come arte da cesso, luogo prediletto delle funzioni corporali e emotive raccontate fin qui.
Scrive fumetti e scrive di fumetti, poi scrive anche canzoni e le canta, insieme a quelle degli altri che gli piacciono. Il suo sito è www.francescopelosi.it.