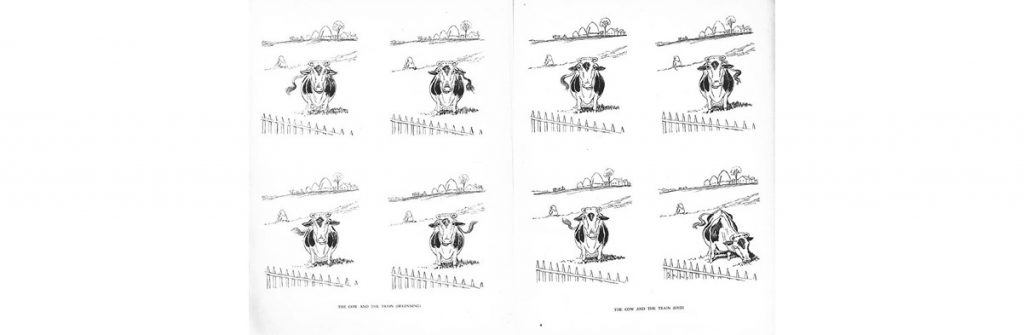Ho letto Crescere che palle di Sarah Andersen. Come spesso accade, la traduzione del titolo tradisce lo spirito originale dell’opera, Adulthood is a Mith, più o meno “Essere adulti è un mito”, un’affermazione che potrebbe traumatizzare un adolescente ma che sarebbe condivisa da qualsiasi adulto di mia conoscenza. Ci hanno insegnato che esiste una linea divisoria tra essere adulti e non esserlo ancora, ma questa linea è un mito, perché è così difficile, a qualunque età, sentire le certezze che il mondo dei nostri genitori ci avevano promesso.
Credo che il titolo italiano e l’immagine di copertina possano far apparire questo libro vagamente infantile a un lettore abituale di fumetti, rivolto com’è a quella fetta di pubblico che – perdonate la bibliotecaria – viene chiamata dall’industria editoriale “giovani adulti”. Una produzione molto eterogenea, accomunata dai protagonisti giovani; ma se bastasse questa caratteristica, vogliamo parlare del giovane Werther? Cambiate la grafica di copertina e diventa semplicemente un libro.

Adulthood è una raccolta di vignette dal tratto apparentemente molto semplice: sembra pennarello nero su fondo bianco. La banalità di questa descrizione non rende giustizia alla complessità del fumetto.
Quello che Andersen vuole raccontarci, con una semplicità essenziale in cui basterebbe cambiare un dettaglio per rendere la vignetta banale, mi ha fatto pensare ai Peanuts di Schulz. Qui ho trovato le espressioni, gli umori e le riflessioni di una protagonista femmina cisgender che è abbastanza giovane da avere ancora il ciclo mestruale, ma in cui chiunque si può identificare. Ho trovato interessante, perché non l’avevo mai incontrata prima, la rappresentazione dell’utero e delle ovaie come personaggi, spaccando certamente la raccolta in due parti. Una risulta certamente più familiare a una donna, ma l’altra, cioè la quasi totalità del libro, è comprensibile e toccante per chiunque, maschio o femmina, soffra di nevrosi e depressione.
Nelle storie che parlano del ciclo mestruale, e di come influisca sull’umore – una questione che, come ha detto qualcuno che non ricordo, «se colpisse anche gli uomini sarebbe risolta da tempo» – utero e ovaie cospirano contro la sanità mentale delle donne. La loro è una un’alleanza che non rimanda alla «mucca col vitello, la pecora e l’agnello», ma a stati di depressione, ansia, agitazione che possono sconfinare nel panico e in una inspiegabile disperazione. Sia l’utero che le ovaie hanno faccine espressive e una voce precisa. Sono coalizzati contro di noi, nella nostra pancia. È interessante, perché mestruazioni, a differenza della gravidanza e del parto, sono un argomento quasi tabù per la gran parte delle storie che ho letto, qualunque fosse il linguaggio usato per raccontarle, nonostante siano fenomeni intimamente legati alla fisicità femminile.
Ma tutte le altre striscia riguardano la difficoltà di inserirsi in un mondo in cui viviamo soggetti a una pressione continua da parte del lavoro, della socializzazione, delle scadenze, delle aspettative proprie o altrui.
La reazione della protagonista è rifugiarsi in casa, mettersi in pigiama e nascondersi sotto le coperte. Qualunque problema sembra insormontabile, le relazioni con gli altri sono difficili e il cervello tende a confondere interazioni che per “altri” sono normali con la sensazione di trovarsi in un ambiente ostile. L’amore è esclusivamente fonte di angoscia, basata sulla convinzione di essere impossibile da amare. Il rapporto con gli altri è visto come una violenza a cui non ci si può sottrarre, se non rinchiudendosi in una bolla di finti sorrisi che, nell’illusione di proteggerti, ti confina in un mondo di sensazioni che vanno dal disagio all’ansia acuta. Tutto tende a tramutarsi nel bisogno di tornare a rifugiarsi nella propria tana, nel proprio letto, che Andersen rappresenta come una cuccia familiare che ha per tetto le coperte.
Naturalmente ci sono anche momenti di gioia, ma per lo più solitari: l’amore per i libri, l’accumulo di peluche…
Le uniche interazioni possibili sembrano quelle con il coniglietto che le fa da sidekick, un grillo parlante mai ascoltato, ma solo amato. È la parte più sana della mente, quella che ci impedisce di nebulizzarci in uno sciame di atomi. Mica la ascoltiamo sempre, ma è confortante sapere che c’è.

Una delle ossessioni della protagonista del fumetto di Andersen è la pressione continua, da parte degli amici e delle amiche o, apparentemente, della prima femmina che passa, dai trenta ai cento anni, sulla sua decisione di non avere figli. Una delle pagine che mi hanno fatto più ridere è quella in cui , in risposta alla centesima domanda, inevitabile, su come possa incanalare l’istinto materno (considerato inevitabile nelle donne): la striscia termina con la protagonista che si mostra gioiosa e sicura di essere presa per una pazza inspiegabile, con le braccia cariche di peluche. Forse ho riso tanto perché, se veniste a casa mia, trovereste scaffali appositamente dedicati ai peluche: alcuni hanno addirittura la mia età, superstiti morbidi dell’infanzia profonda, altri sono più recenti, e durante il lockdown ne ho comprati altri due: un Totoro di discrete dimensioni e il Drago di Spirited Away di Miyazaki. Insomma, li colleziono, con la scusa di fare promozione della lettura ai bambini. La verità è che li amo, uno per uno. Arrivo al punto, nei mercati selvaggi come l’ultimo tratto del Balôn di Torino, di guardarmi attentamente intorno per “salvare i peluche”, recuperandoli da mucchi eterogenei di ciarpame. Sono tutti sporchi e miserabili finché non li lavo bene con l’ammorbidente e li riporto alla loro soffice e consolatoria forma originale. Potrei parlarvi di conigli, di una strana quantità di tigri, di orsi su orsi. Ho persino trovato un piccolo gorilla. Nella mia fantasia sono un’allargatissima e amorosa famiglia queer.
Non so cosa fanno le persone, per incanalare questi obbligatori desideri di maternità e paternità, ma ho un amico che dedica il proprio affetto paterno alle chitarre, che compra con frequenza allarmante e tratta con la dolcezza che si riserverebbe a un bambino.
Mi rifiuto, quindi, di pensare che questo fumetto se lo possano godere solo le donne: qualunque persona nevrotica apprezzerà la cura e la grandissima ironia con cui viene trattata la nostra fragilità. Atteggiamenti, pensieri e paranoie della protagonista dei disegni di Andersen sono comprensibili da tutti coloro che provano difficoltà verso la vita.
Ignoro se esista un’altra categoria. Tipo I Risolti. Se sì, presentatemeli.
Per quanto riguarda la questione del Segno, confesso che a me i fumetti disegnati così piacciono, mi piace la loro immediatezza, mi piace l’occupazione minimale dello spazio bianco che riesce a rappresentare in modo semplice situazioni complesse. Non sono tra quelli che hanno cominciato a leggere e a amare i fumetti da piccoli – con l’eccezione dei Peanuts e di B.C. di Johnny Hart, le avventure di un gruppo di uomini e donne dell’età della pietra che precedevano, nella collana Urania, l’ultimo racconto. La prima scoperta dell’incanto dei fumetti è giunta con Watchmen. E solo decine di anni dopo, grazie all’incontro con persone che invece i fumetti li amano da sempre, che ho cominciato veramente a esplorare questo modo del racconto. Resto comunque una outsider: per esempio, mi è chiara la loro fascinazione per Moebius, ma le sue tavole perfette mi risultano insopportabili, come una chiesa barocca che mi crollasse in testa. Amo gli acquerelli di Gipi, il magnifico bianco e nero di David B., lo splendore di Watchmen, le tenere avventure degli Young Avengers.
Purtroppo, al contrario di quello che sostiene un amico molto appassionato ed esperto, e cioè che «i fumetti non si leggono, si guardano» io, che sono una lettrice insaziabile di romanzi, non posso fare a meno di vedere una commistioni inestricabile tra segno e parola.
Per esempio, di Gipi amo particolarmente due fumetti: uno è Questa è la stanza, colori sfumati e disegno impeccabile, che contiene alcune tavole in cui vedi una band di ragazzi scalcagnati e magrolini che suona qualcosa che è chiaramente punk, e BAM ti fa sentire la musica picchiata forte e le parole urlate dal cantante. Un pezzo fondamentale della mia vita di cantante, il piccolo seme della persona che sono diventata. L’altro è La mia vita disegnata male, che vive di un bianco e nero espressivo e straziante, in cui mi è impossibile non identificarmi con il protagonista, nonostante anche io, come la protagonista di Adulthood, sia una femmina cisgender eterosessuale: l’angoscia della sua crisi psicotica mi riporta a frammenti della mia vita, a momenti di totale confusione che non hanno avuto un inizio preciso e continuo a sperimentare anche oggi.
Come per i libri, per me esistono solo fumetti belli e fumetti brutti, indipendentemente dall’abilità del disegno o dal contenuto della storia. E, sinceramente, non me ne importa. Vedo la narrazione come un prisma della realtà. E per me, nata lettrice di romanzi e racconti, i fumetti sono stati semplicemente la scoperta straordinaria di un linguaggio che non conoscevo. Quindi, fregandomene altamente del parere di qualunque critico serissimo, amo Sarah Andersen, che riesce a unire ironia verbale ed espressività del disegno. In ognuno di quei disegni vedo un amore per la vita, così difficile, a tratti insostenibile.
E l’amore, per la vita, per i libri, per le mie famiglie di peluche è, chiaramente, una delle forma della bellezza, che è queer e consente a chiunque si senta toccato nel cuore di condividerla.
Vive in un condominio affollato e rumoroso. Le sue coinquiline e i suoi coinquilini hanno fatto di tutto nella vita: bibliotecarie, animatrici culturali, speaker alla radio, cantanti, mogli, mariti, amanti, complici… Ora ascolta tutte e tutti e sembra abbia visto, letto e goduto di ogni cosa. Me lei sa che quell’obiettivo non è stato ancora raggiunto e che si trova alla deriva in un punto indeterminato del processo.